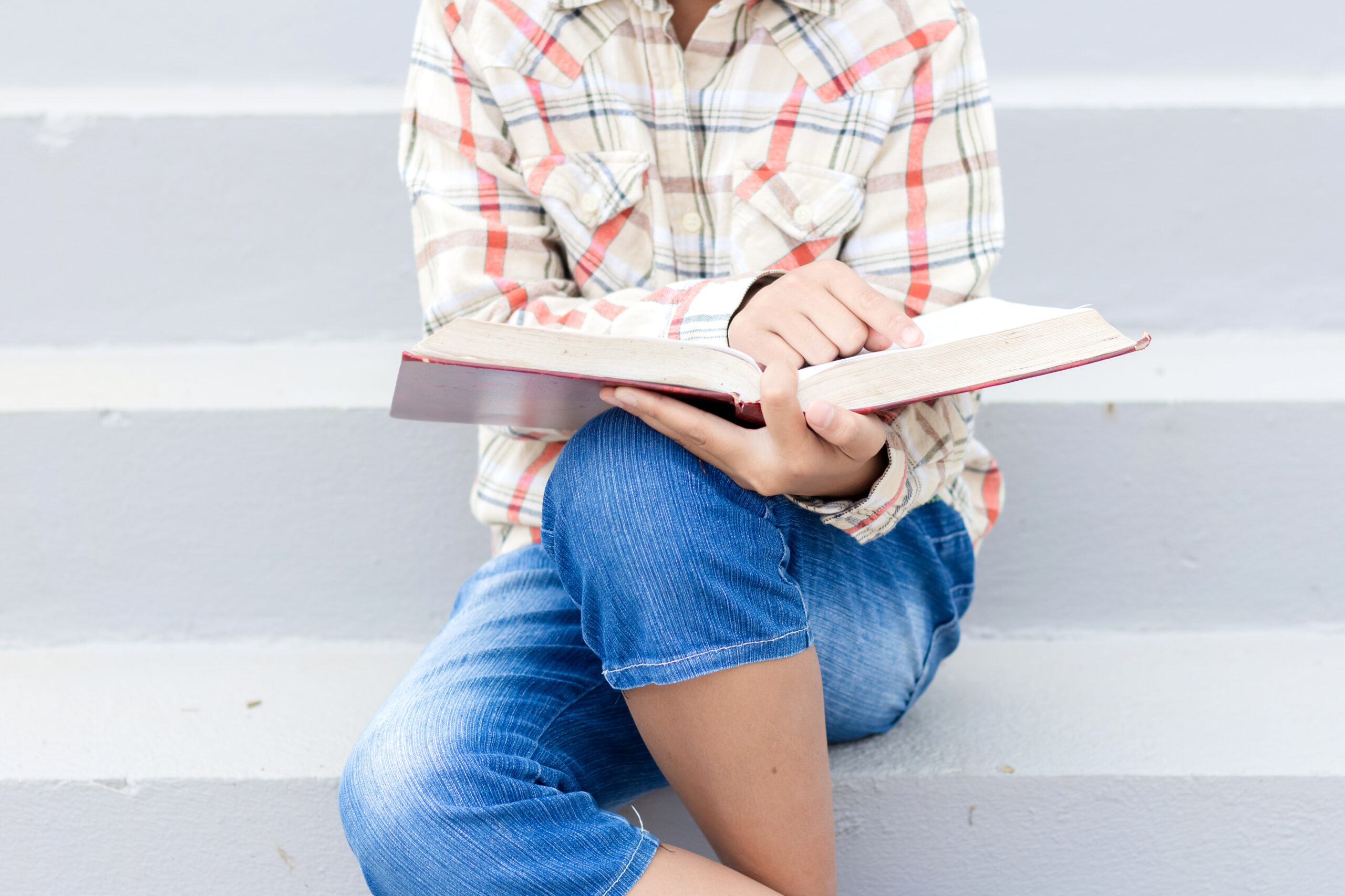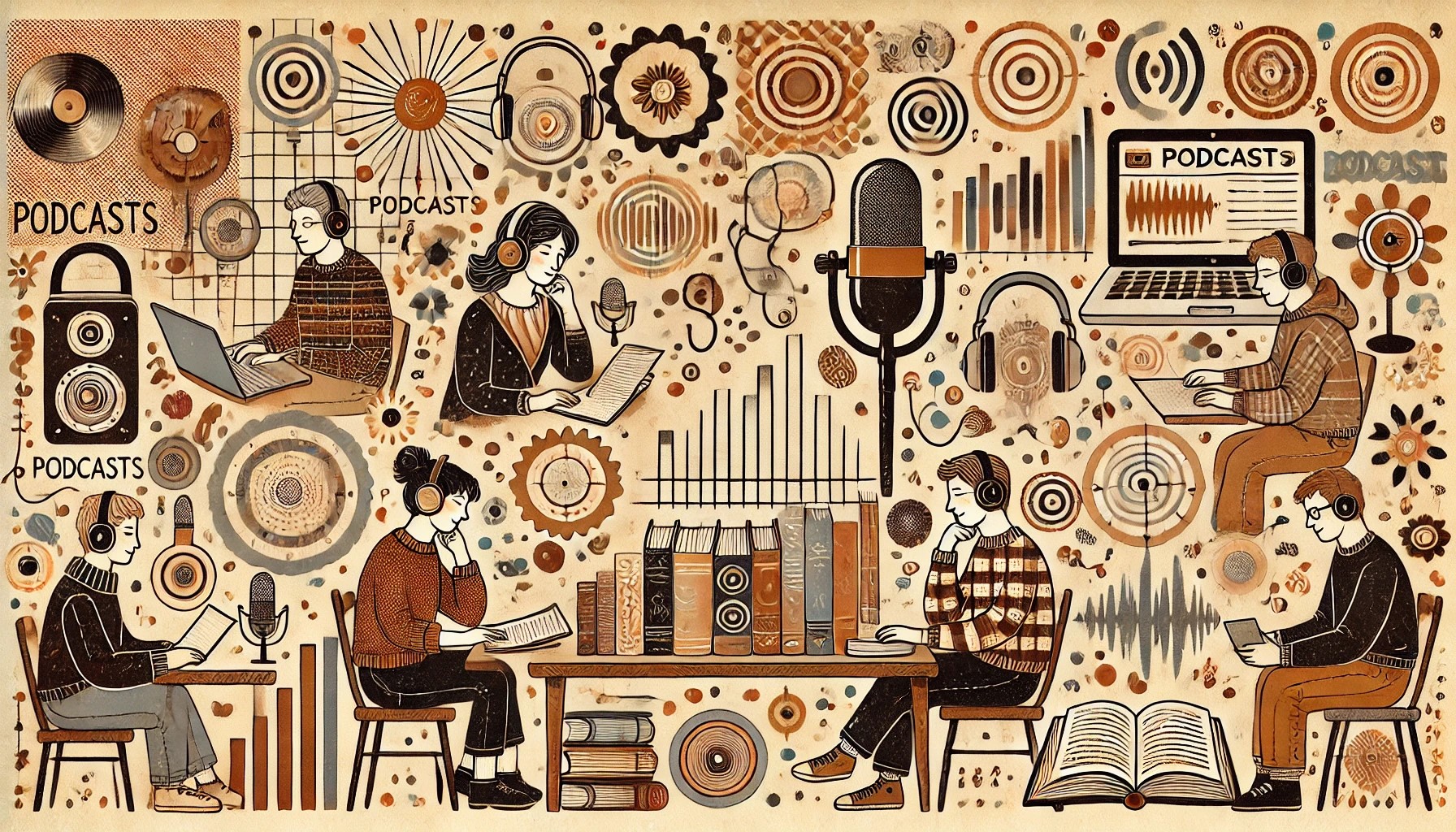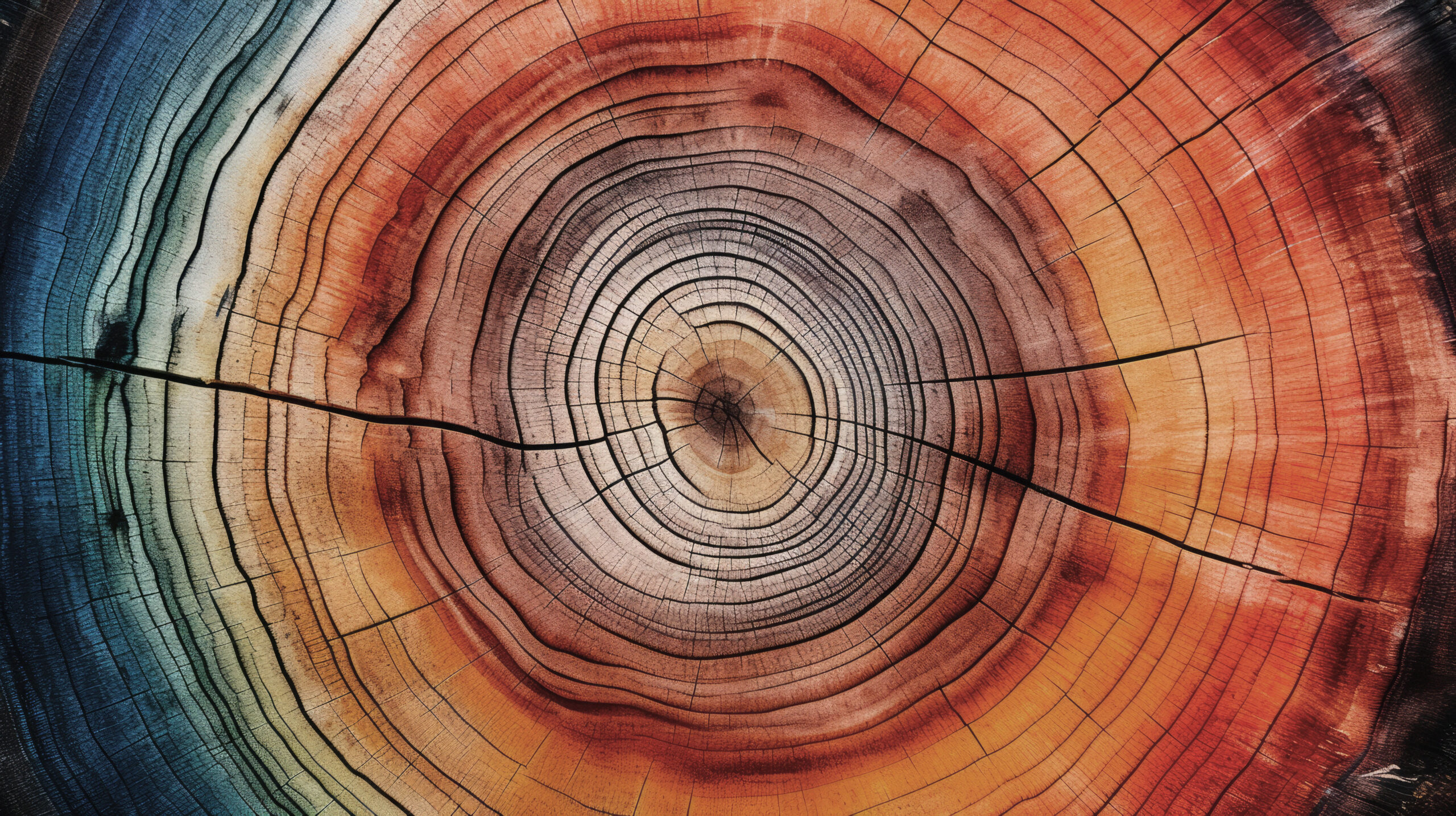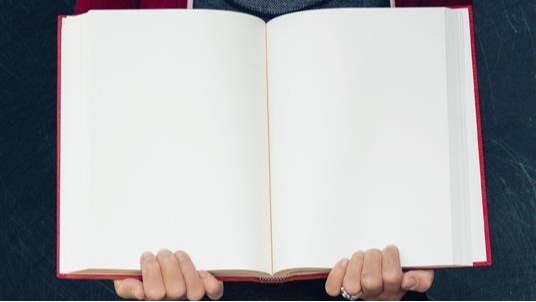
Dettaglio di copertina del romanzo: Una rivoluzione sentimentale

L’apprendimento e la ricerca nell’istruzione © Istock – Kobus Louw
Come si conciliano i tempi della scrittura, e i numerosi impegni che comporta la promozione dei libri, con quelli dell’insegnamento?
Mi organizzo bene e ho molta capacità di concentrazione, questo è il mio principale pregio, credo: riesco a concentrarmi su un compito da svolgere, una lettura, la scrittura di un pezzo per il giornale, la preparazione di una lezione, senza farmi distrarre. È quello che cerco di insegnare ai miei alunni che invece hanno spesso difficoltà nel concentrarsi, lavoriamo in classe per allungare i tempi di attenzione, è una specie di “stretching della mente”, come dico sempre loro.
Le studentesse sono molto interessate alle tematiche di genere e anche attente a “istruire” i loro compagni di classe e a bacchettarli quando, senza pensarci, scappa una frase o un’espressione sessista. E loro sono diventati più attenti e consapevoli.
Ai miei studenti la poesia piace molto, dopo l’iniziale diffidenza cominciano anche loro a misurarsi con la scrittura poetica, che è molto adolescenziale, tutti da ragazzi hanno scritto poesie, e inoltre è il territorio più vicino a quello della musica, quello che padroneggiano maggiormente.
Viola Ardone, nata a Napoli nel 1974, ha lavorato nel campo dell’editoria e attualmente insegna italiano e latino al liceo. Ha pubblicato per Salani i romanzi La ricetta del cuore in subbuglio (2012) e Una rivoluzione sentimentale (2016). Nel 2019 ha pubblicato per Einaudi Il treno dei bambini, tradotto in oltre trenta lingue, da cui Cristina Comencini ha tratto l’omonimo film nel 2024. Sono seguiti, sempre per Einaudi, Oliva Denaro (2021) e Grande meraviglia (2023). Collabora inoltre con il “Corriere del mezzogiorno”, “la Repubblica”, “La Stampa”, “L’Espresso”.