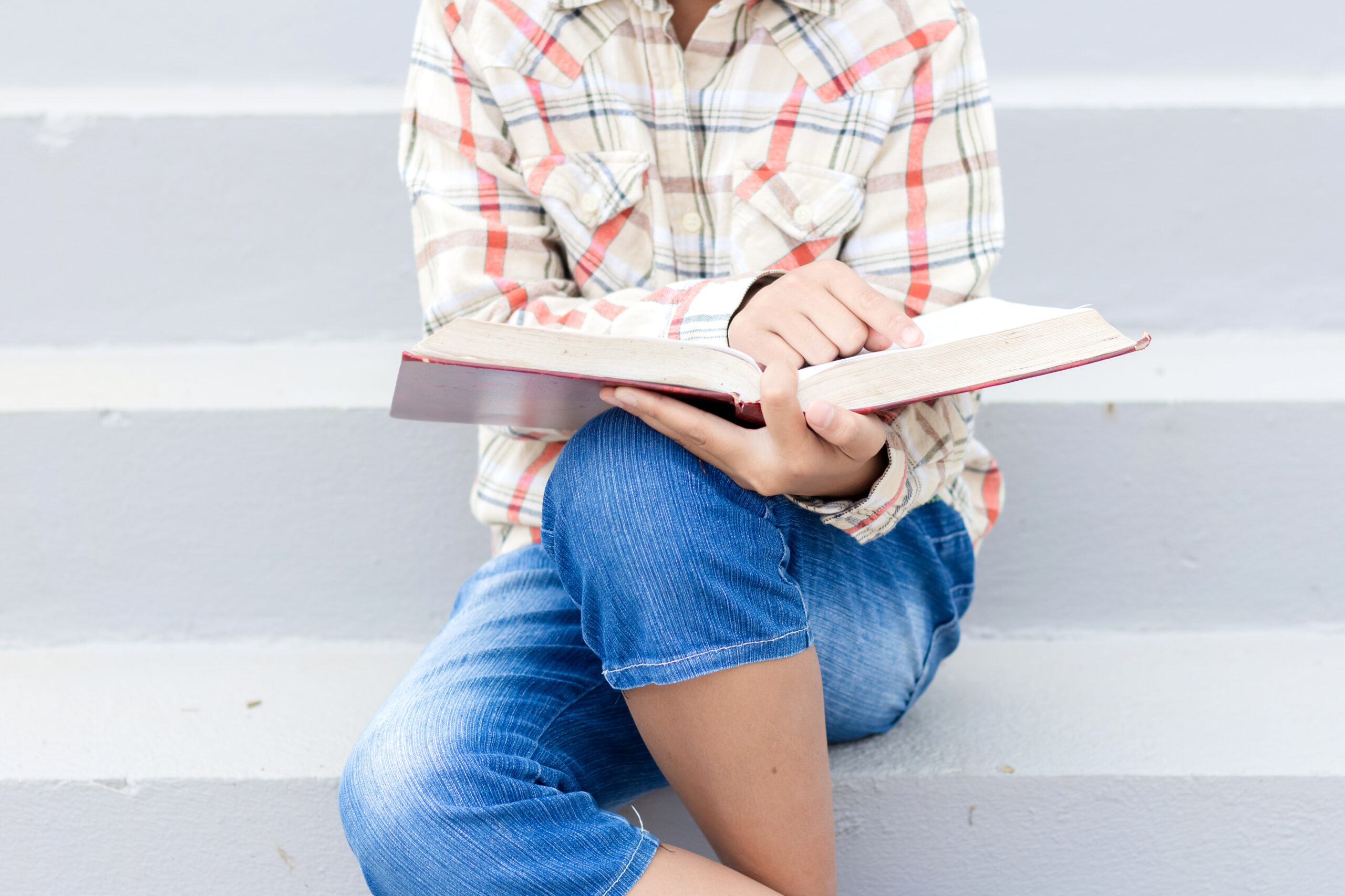L’aspettativa di vita è un parametro che riassume i tassi di mortalità di tutte le fasce d’età in un determinato anno.
L’aspettativa di vita può diminuire anche in maniera repentina, se si verificano eventi eccezionali come epidemie, guerre, catastrofi naturali o ambientali. La pandemia di influenza spagnola, nel 1918, avendo fatto molte vittime tra i più giovani, aveva causato una forte riduzione della speranza di vita, di gran lunga superiore rispetto a quella provocata dalla Prima guerra mondiale appena conclusa. Qualcosa di analogo è avvenuto in Africa negli anni Ottanta, in seguito all’epidemia di AIDS.
In Italia l’aspettativa di vita è stata finora in continua crescita, grazie a progressi sanitari, economici e sociali che spesso diamo per scontati. La popolazione molto anziana che raggiunge oggi età ragguardevoli ci offre la gioia di godere solitamente a lungo della compagnia di genitori, nonni, bisnonni. Allo stesso tempo il continuo allungamento delle esistenze, accanto a una forte riduzione delle nascite, pone sfide sociali notevoli, su cui è importante interrogarsi.

Generazioni a confronto
Tipicamente ci sarà lo studente che domanderà come mai sua nonna, che ha fumato e bevuto alcolici tutta la vita, è ancora perfettamente in forma a 98 anni. L’eccezione è utilissima a spiegare che l’aspettativa di vita è una previsione statistica che ha, cioè, un valore generale: per la media della popolazione e non per il singolo individuo. Statisticamente, dunque, per una nonna ancora arzilla a quasi cent’anni, nonostante abitudini di vita non proprio salutari, ci saranno molti più nonni e nonne che, avendo seguito i medesimi comportamenti, a quell’età o non sono proprio arrivati o non stanno altrettanto bene.
Parlarne a scuola con i ragazzi può aiutarli a essere più consapevoli della realtà, a scegliere uno stile di vita salutare. E anche a impadronirsi di basilari strumenti statistici
Innanzitutto occorrono alcuni dati. Prendiamo per esempio le persone che vivono in Italia: bisogna sapere di quanti individui si tratta, suddivisi per età e per sesso. Inoltre occorre conoscere quante persone, sempre in Italia, muoiono ogni anno e a quale età. Tali informazioni sono raccolte con assiduità dagli uffici di statistica come l’ISTAT e sono consultabili pubblicamente.
Una volta raccolti i tassi di mortalità per ciascuna fascia d’età, si costruiscono le cosiddette tavole di mortalità. Si tratta di tabelle con cui, con sistemi di calcolo matematico-statistico standardizzati, è possibile descrivere le probabilità di sopravvivenza o di morte per ogni età della vita. Per fare un esempio pratico, immaginiamo di avere 100.000 bambini appena nati. La tavola ci mostrerà, anno dopo anno, quanti di questi bambini saranno verosimilmente ancora vivi a ogni età: quanti arriveranno a 10 anni, quanti a 20, quanti a 30 e così via, fino all’età in cui, prevedibilmente, nessuno sarà più in vita.
A questo punto come si arriva al numero che rappresenta l’aspettativa di vita? In pratica si fa una specie di media degli anni vissuti da tutte le persone. Tornando all’esempio dei 100.000 bambini immaginari, prima si sommano tutti i compleanni, per così dire, che ci si aspetta che possano essere festeggiati. Quindi si divide tale somma per 100.000, ossia il numero di partenza di tutti i nati vivi. Il risultato ci dice quanti anni può raggiungere, sempre in media, una persona di una determinata popolazione.