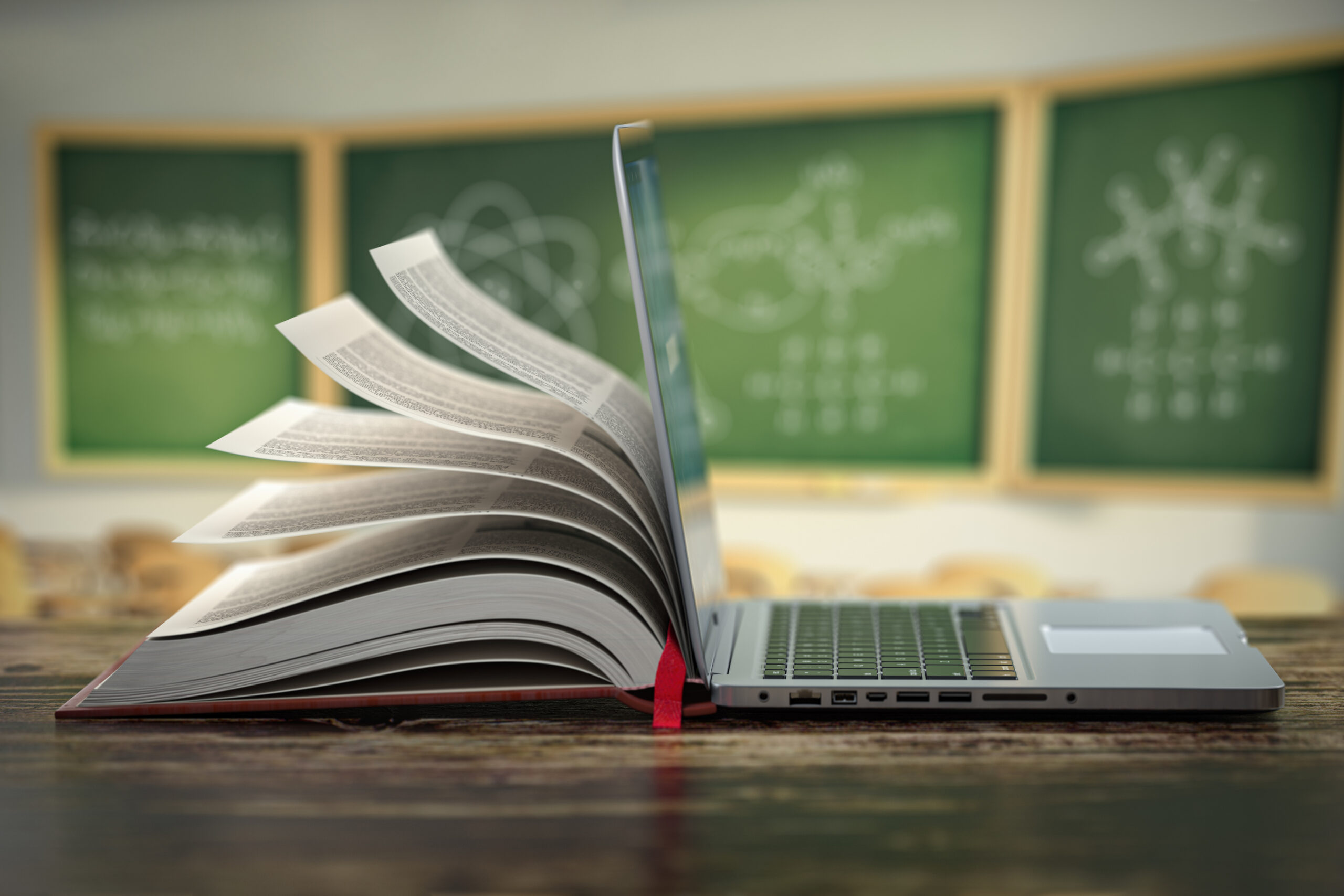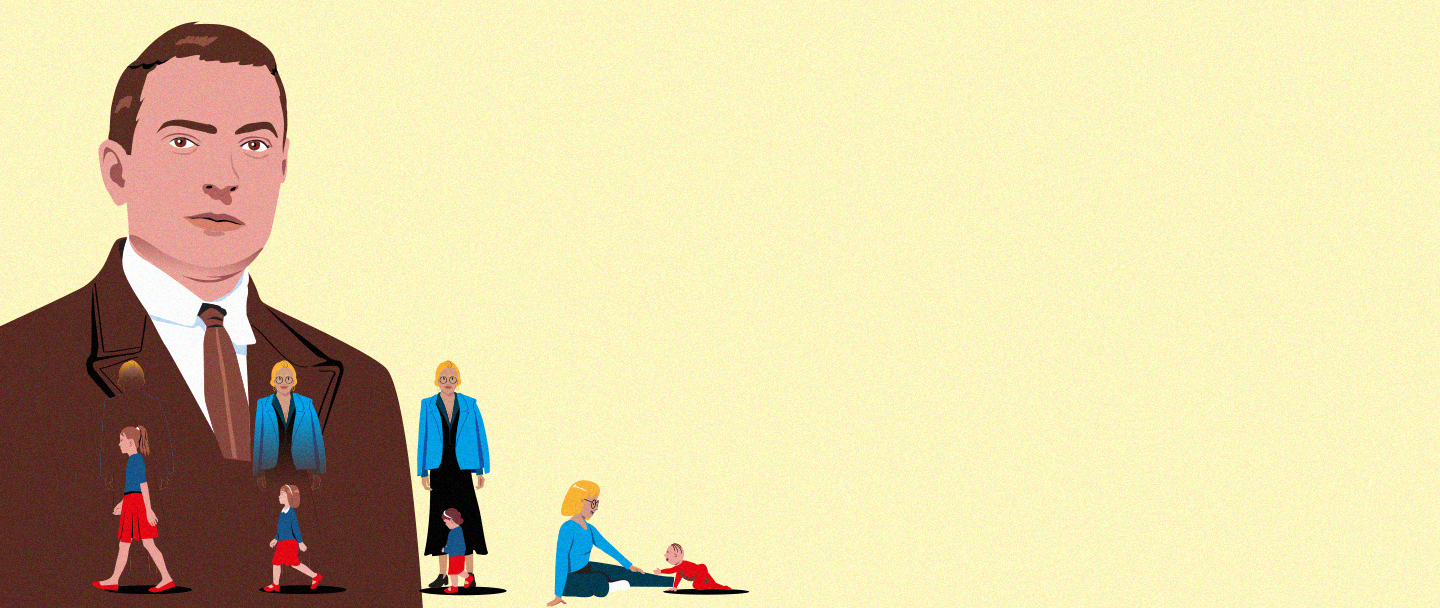Paulo Reglus Neves Freire è noto per la sua pedagogia dell’emancipazione, che considera l’educazione uno strumento di liberazione e di trasformazione sociale, in particolare per gli individui e i gruppi soggetti a meccanismi di oppressione.
Il suo percorso inizia a Recife, nel nord-est del Brasile, dove nasce nel 1921. Nonostante la sua famiglia appartenga alla classe media, crescendo fa esperienza della profonda disuguaglianza sociale che affligge l’area in cui vive, caratterizzata da un tasso di analfabetismo del 60% e ulteriormente impoverita dalla Grande Depressione del 1929. Durante gli anni universitari presso la facoltà di Giurisprudenza di Recife, intraprende la professione d’insegnante di portoghese, avvicinandosi allo studio della psicologia del linguaggio. Condivide la passione per la pedagogia con Elza Maia Costa de Oliveira, maestra di scuola primaria che lo avvicina all’insegnamento e che lavorerà con lui per gran parte della vita. Nel 1944 si sposano: insieme avranno cinque figli.
Alla fine degli studi universitari, alla possibilità di diventare avvocato preferisce sempre e comunque l’insegnamento. Negli anni Sessanta partecipa al Movimento della Cultura Popolare, fondato all’inizio del decennio con l’ambizione di promuovere l’alfabetizzazione e la partecipazione attiva del popolo alla vita sociale e politica utilizzando la cultura come strumento di trasformazione. In questo periodo Freire sviluppa un pensiero orientato al riscatto delle fasce più fragili della società, in cui pedagogia e politica dialogano: in quest’ottica la liberazione dei popoli inizia dall’accesso a una cultura che non venga imposta dall’alto da parte di una classe dominante interessata a conservare il suo potere, ma che scaturisca da uno scambio tra docenti e studenti finalizzato allo sviluppo del pensiero critico. Perché questo accada occorre ribaltare la didattica tradizionale, con il docente che, in posizione sopraelevata, dispensa conoscenze, e impostare una nuova relazione di reciprocità e dialogo con gli studenti.
Il suo percorso inizia a Recife, nel nord-est del Brasile, dove nasce nel 1921. Nonostante la sua famiglia appartenga alla classe media, crescendo fa esperienza della profonda disuguaglianza sociale che affligge l’area in cui vive, caratterizzata da un tasso di analfabetismo del 60% e ulteriormente impoverita dalla Grande Depressione del 1929. Durante gli anni universitari presso la facoltà di Giurisprudenza di Recife, intraprende la professione d’insegnante di portoghese, avvicinandosi allo studio della psicologia del linguaggio. Condivide la passione per la pedagogia con Elza Maia Costa de Oliveira, maestra di scuola primaria che lo avvicina all’insegnamento e che lavorerà con lui per gran parte della vita. Nel 1944 si sposano: insieme avranno cinque figli.
Alla fine degli studi universitari, alla possibilità di diventare avvocato preferisce sempre e comunque l’insegnamento. Negli anni Sessanta partecipa al Movimento della Cultura Popolare, fondato all’inizio del decennio con l’ambizione di promuovere l’alfabetizzazione e la partecipazione attiva del popolo alla vita sociale e politica utilizzando la cultura come strumento di trasformazione. In questo periodo Freire sviluppa un pensiero orientato al riscatto delle fasce più fragili della società, in cui pedagogia e politica dialogano: in quest’ottica la liberazione dei popoli inizia dall’accesso a una cultura che non venga imposta dall’alto da parte di una classe dominante interessata a conservare il suo potere, ma che scaturisca da uno scambio tra docenti e studenti finalizzato allo sviluppo del pensiero critico. Perché questo accada occorre ribaltare la didattica tradizionale, con il docente che, in posizione sopraelevata, dispensa conoscenze, e impostare una nuova relazione di reciprocità e dialogo con gli studenti.
“Non ci si possono aspettare risultati positivi da un programma di azione educativo o politico che non rispetti la particolare visione del mondo detenuta dalla gente. Tale programma costituisce un’invasione culturale, nonostante le buone intenzioni”.
Pedagogia degli oppressi, 1970
In qualità di direttore del Dipartimento di educazione dello Stato di Pernambuco, nel 1962, mette a punto un programma per insegnare a leggere e scrivere a trecento lavoratori dei campi di canna da zucchero di Angicos: ci riesce in soli quarantacinque giorni. Anche grazie alla dimostrazione dell’efficacia dei suoi metodi didattici, è invitato a dirigere il Programma Nazionale di Alfabetizzazione, applicando su larga scala il suo modello.
I risultati raggiunti dal programma spaventano i gruppi conservatori, timorosi che un’educazione finalizzata all’emancipazione possa incitare le classi subalterne alla ribellione. Con il colpo di Stato militare del 1964, Freire è accusato di sedizione e, dopo settanta giorni di prigionia, intraprende la via dell’esilio in Cile.
Gli anni vissuti lontano dal Brasile, per quanto sofferti, sono proficui per la messa a punto delle sue teorie pedagogiche. Nel 1967 scrive L’educazione come pratica di libertà e inizia la sua opera più celebre: Pedagogia degli oppressi. In questi testi, Freire sviluppa ulteriormente la sua idea di pedagogia critica. Centrale nella sua visione è il concetto di do-discenza, un ribaltamento della relazione tradizionale tra docente e discente in cui, secondo Freire, l’insegnante sembra depositare conoscenze nello studente come fosse un “conto bancario”. Il pedagogista, invece, promuove un dialogo in cui docente e studenti possano apprendere reciprocamente l’uno dall’altro, secondo il postulato che “non c’è insegnamento senza apprendimento”.
I risultati raggiunti dal programma spaventano i gruppi conservatori, timorosi che un’educazione finalizzata all’emancipazione possa incitare le classi subalterne alla ribellione. Con il colpo di Stato militare del 1964, Freire è accusato di sedizione e, dopo settanta giorni di prigionia, intraprende la via dell’esilio in Cile.
Gli anni vissuti lontano dal Brasile, per quanto sofferti, sono proficui per la messa a punto delle sue teorie pedagogiche. Nel 1967 scrive L’educazione come pratica di libertà e inizia la sua opera più celebre: Pedagogia degli oppressi. In questi testi, Freire sviluppa ulteriormente la sua idea di pedagogia critica. Centrale nella sua visione è il concetto di do-discenza, un ribaltamento della relazione tradizionale tra docente e discente in cui, secondo Freire, l’insegnante sembra depositare conoscenze nello studente come fosse un “conto bancario”. Il pedagogista, invece, promuove un dialogo in cui docente e studenti possano apprendere reciprocamente l’uno dall’altro, secondo il postulato che “non c’è insegnamento senza apprendimento”.
Sulla scia di Dewey, che aveva posto la democrazia al centro della riflessione pedagogica, Freire arriva a ipotizzare la pratica democratica come metodo pedagogico, ancor prima che come obiettivo dell’educazione, suggerendo di abolire la verticalità della relazione docente/studente e immaginando l’insegnante non tanto come una figura dedita all’esercizio dell’autorità, quanto piuttosto alla facilitazione della partecipazione da parte degli studenti.
Al modello educativo tradizionale, che accusa di paternalismo, Freire contrappone un metodo d’insegnamento incentrato su quello che definisce problem-posing, un processo che sfida lo studente a una profonda comprensione del problema attraverso l’individuazione di tutte le informazioni reperibili e il ricorso al proprio senso critico. Lo stesso processo è alla base della coscientizzazione, termine utilizzato da Freire per definire il percorso di consapevolezza sviluppato da un individuo o da un gruppo riguardo alla propria realtà, innanzitutto sociale, e ai meccanismi di oppressione cui è sottoposto. Questa presa di coscienza costituisce il primo passo per la trasformazione della propria condizione.
Le teorie sviluppate da Freire riscuotono un successo internazionale, influenzando in Sud America e in tutto il mondo movimenti come la teologia della liberazione (corrente di pensiero cattolica che sottolinea l’importanza dell’emancipazione sociale e politica degli oppressi) e gli studi sul colonialismo e la decolonizzazione.
Nel 1969 a Freire viene offerto un posto di visiting professor all’università di Harvard e, in seguito, viene chiamato a Ginevra in qualità di consigliere educativo per il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Qui Freire ha modo di lavorare alla riforma educativa del sistema scolastico delle colonie portoghesi africane, in particolare in Mozambico e Guinea-Bissau.
Il suo esilio finisce nel 1979 quando, finalmente tornato in Brasile, si unisce al Partito dei Lavoratori e riprende le fila del suo progetto di alfabetizzazione degli adulti, partendo dalla città di San Paolo. Sempre convinto della necessità di dialogo tra politica e pedagogia, nel 1988 diventa assessore all’Educazione nel Comune di San Paolo, dove fonda anche l’Istituto Paulo Freire, centro studi in cui apre nuove frontiere, come quella dell’eco-pedagogia, indirizzata a un’educazione delle nuove generazioni alla crescita sostenibile e a una cultura del rispetto della natura e dei diritti umani.
Fino alla fine della sua vita, nel 1997, la chiave di volta del pensiero di Freire rimane la convinzione che l’educazione sia lo strumento d’elezione per un percorso di liberazione personale e collettiva. In questa prospettiva il sistema scolastico dovrebbe avere come obiettivo principale non tanto quello di “addestrare” o trasmettere nozioni, quanto piuttosto quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per trasformare il mondo. L’insegnante, in questo senso, ha un compito inevitabilmente politico, in quanto può decidere se guidare gli studenti lungo un percorso che miri passivamente alla conservazione di uno stato di realtà, anche quando ingiusto, oppure renderli consapevoli dell’esistenza di problemi e ingiustizie, sviluppando in loro la fiducia di poter cambiare la società che abitano.
Le teorie sviluppate da Freire riscuotono un successo internazionale, influenzando in Sud America e in tutto il mondo movimenti come la teologia della liberazione (corrente di pensiero cattolica che sottolinea l’importanza dell’emancipazione sociale e politica degli oppressi) e gli studi sul colonialismo e la decolonizzazione.
Nel 1969 a Freire viene offerto un posto di visiting professor all’università di Harvard e, in seguito, viene chiamato a Ginevra in qualità di consigliere educativo per il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Qui Freire ha modo di lavorare alla riforma educativa del sistema scolastico delle colonie portoghesi africane, in particolare in Mozambico e Guinea-Bissau.
Il suo esilio finisce nel 1979 quando, finalmente tornato in Brasile, si unisce al Partito dei Lavoratori e riprende le fila del suo progetto di alfabetizzazione degli adulti, partendo dalla città di San Paolo. Sempre convinto della necessità di dialogo tra politica e pedagogia, nel 1988 diventa assessore all’Educazione nel Comune di San Paolo, dove fonda anche l’Istituto Paulo Freire, centro studi in cui apre nuove frontiere, come quella dell’eco-pedagogia, indirizzata a un’educazione delle nuove generazioni alla crescita sostenibile e a una cultura del rispetto della natura e dei diritti umani.
Fino alla fine della sua vita, nel 1997, la chiave di volta del pensiero di Freire rimane la convinzione che l’educazione sia lo strumento d’elezione per un percorso di liberazione personale e collettiva. In questa prospettiva il sistema scolastico dovrebbe avere come obiettivo principale non tanto quello di “addestrare” o trasmettere nozioni, quanto piuttosto quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per trasformare il mondo. L’insegnante, in questo senso, ha un compito inevitabilmente politico, in quanto può decidere se guidare gli studenti lungo un percorso che miri passivamente alla conservazione di uno stato di realtà, anche quando ingiusto, oppure renderli consapevoli dell’esistenza di problemi e ingiustizie, sviluppando in loro la fiducia di poter cambiare la società che abitano.
“Non potendo mai essere neutra, l’educazione può porsi tanto al servizio della decisione, della trasformazione del mondo, dell’inserimento critico in esso, quanto al servizio dell’immobilizzazione, del persistere di strutture ingiuste, dell’adeguamento degli esseri umani a una realtà considerata inattaccabile. Per questo parlo di educazione o di formazione, mai di mero addestramento. Perciò, non solo parlo e difendo, ma vivo anche una pratica educativa radicale, che stimola la curiosità critica a cercare sempre le ragioni ultime dei fatti.”
Il diritto e il dovere di cambiare il mondo, 2021