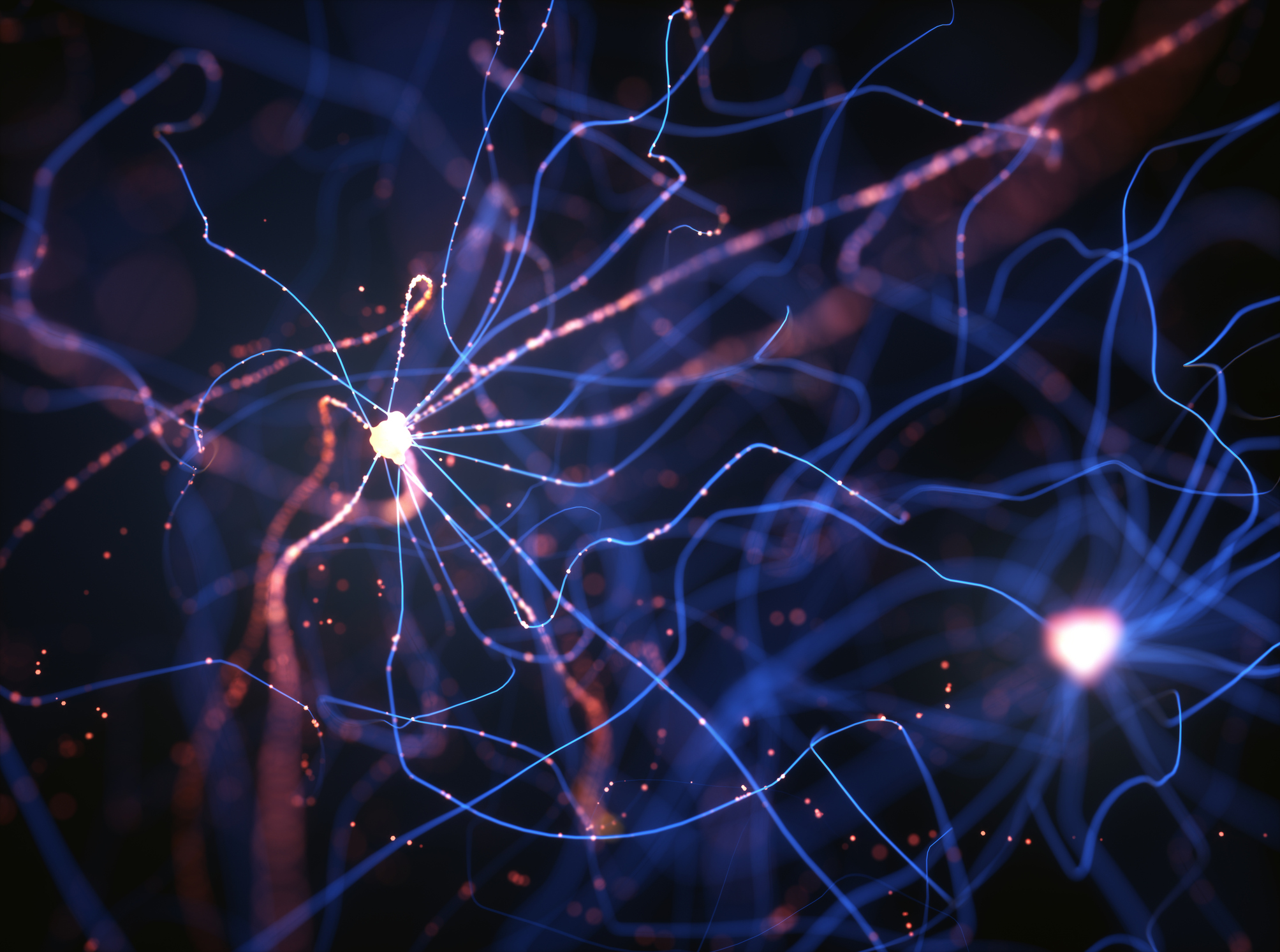In che modo crescere e apprendere si sovrappongono nei primi sei anni della nostra vita?
Fino all’età di due anni il bambino è come una spugna: assorbe tutto. A livello neurologico, ciò si traduce nell’aumento della produzione di neuroni e delle loro interconnessioni mediante la formazione di sinapsi. La prima fase di crescita riguarda il contatto del bambino con la madre, passando dalla simbiosi alla possibilità di sentirsi in contatto con lei, ma al di fuori del suo corpo. Segue la fase della prensione, che realizza la possibilità di conoscere e dominare l’ambiente esterno attraverso la mano. All’ottavo mese i bambini, con la conquista dell’angoscia per l’estraneo, differenziano il noto dal non conosciuto, condizione che in seguito permetterà loro l’approccio tutelato verso il non noto. Circa all’anno, l’inizio della deambulazione realizza la possibilità di autonomia, che concretizza il processo di individuazione e di affermazione del sé. Nel corso del secondo anno (12-24 mesi), o poco dopo, si definisce il processo di lateralizzazione e la comparsa del gioco simbolico rappresenta la grande conquista futuribile, tramite la rappresentazione agita di ciò che è immaginato e desiderato.
Circa ai 24 mesi anni una quantità notevole di interconnessioni viene distrutta, la cosiddetta potatura sinaptica, permettendo con un processo intelligente di sintesi la permanenza delle connessioni ritenute valide per il successivo percorso evolutivo. Il secondo anno (12-24 mesi) è una fase di grande importanza per lo sviluppo infantile correlato al processo educativo dei genitori tramite l’inizio delle regole tutelanti e di adattamento alla realtà.
Potrebbe fare un esempio di come l’ambiente esterno può influenzare questi primi processi evolutivi?
Più il bambino segue le proprie spinte nel fare conoscenza della realtà di vita e più sarà attivo il processo di sviluppo della comprensione delle proprie potenzialità e dei risultati delle azioni. Dal punto di vista biologico – e quindi delle informazioni contenute nel codice genetico – il bambino mette in atto il proprio processo di sviluppo, i modelli di riferimento evolutivo hanno il duplice compito di comprendere il bambino nella sua unicità e competenza e di indirizzarne, in modo coerente, il percorso evolutivo.
Dopo la delicata fase dei due anni, in quali forme di apprendimento si cimenta il bambino?
Nel corso del terzo anno si struttura la personalità e subentrano le prime difficoltà conflittuali nei confronti dei coetanei e degli adulti. Fra i tre e i quattro anni l’arricchimento della dimensione simbolica, realizzato tramite storie con personaggi immaginari e con il disegno, stimola il bambino a proiettarsi in una dimensione futuribile in rapporto alle proprie aspettative e all’ipotetica valutazione dell’impatto di queste con gli altri. In questa fase i bambini iperattivi richiedono l’agito in confronto al verbalizzato o rappresentato: è il bisogno di sperimentare e capire le cose tramite l’azione; questi bambini parlano e disegnano più tardi rispetto agli altri.

(© helen89, iStock)
Che ruolo hanno gli educatori del nido e della scuola dell’infanzia nell’affiancare e sostenere i processi di apprendimento in bambini così piccoli?
Il ruolo dell’educatore è insegnare al bambino a essere un individuo valido all’interno di una comunità.
In che modo il gioco costituisce una forma di apprendimento, e a quali livelli agisce l’interazione tra coetanei?
Senza dubbio la proposta di giochi strutturati promuove un senso di comunità e di appartenenza, di scambio significativo e di apprendimento insieme, pertanto socializzante. L’educatore durante l’interazione ha la possibilità di osservare e identificare le diverse modalità di risposta dei bambini, il loro significato emotivo, di relazione e di apprendimento.
Fra i due e i tre anni è difficile che i bambini si riuniscano in piccoli gruppi e giochino spontaneamente tra loro; hanno bisogno che sia l’adulto a indicare le regole del gioco; tra i quattro anni e i cinque è più facile che siano i bambini stessi a costituirsi in piccoli gruppi e stabilire le regole.
Nei nidi mi è anche capitato di vedere bambini di età inferiore ai tre anni diventati dei leader di aiuto distribuendo un pezzettino di cioccolato a ciascuno o consolando un altro bambino che piangeva. Il bambino che riceve aiuto apprende a sua volta l’importanza dell’aiuto e realizza che il compagno non rappresenta solo la competizione, ma può essere anche una fonte di comunicazione, di scambio e di reciproco sostegno.
Saper interpretare il linguaggio non verbale di bambini così piccoli diventa uno strumento fondamentale per accompagnarli nel percorso di crescita e apprendimento. Quale contributo può dare, a tale proposito, la figura professionale dello psicomotricista?
Il ruolo dell’educatore è insegnare al bambino a essere un individuo valido all’interno di una comunità. Il ruolo dello psicomotricista risponde invece alla necessità di offrire al bambino un contesto liberatorio in cui realizzare la propria individualità.
La psicomotricista utilizza il gioco – senso-motorio e simbolico – come strumento d’intervento. Attraverso il gioco i bambini usano il linguaggio non verbale per parlare del loro mondo interiore, e la psicomotricista agisce aiutandoli a elaborare e risanare i propri vissuti e facendo percepire loro un maggior controllo sia sui propri processi di crescita sia sulle capacità di adattamento ai contesti familiare, scolastico e sociale.
A mio avviso, ambito scolastico e psicomotorio sono entrambi importanti, ma è bene che il bambino li sperimenti in luoghi e momenti distinti, se e quando sono ritenuti necessari dal neuropsichiatra infantile o dallo psicologo. Sempre auspicabile è il dialogo tra educatori, psicomotricisti, medici e familiari, in modo che le azioni nei confronti del bambino siano coerenti e coordinate.

(© Panama7, iStock)
Quali sono, al giorno d’oggi, i bisogni dei bambini di questa fascia d’età e che ruolo gioca il fatto che vengano proiettati molto precocemente nella realtà virtuale?
Una volta informati delle conseguenze di tale scorretta abitudine, molti genitori hanno interrotto completamente l’esposizione dei loro bambini a cellulari e tablet, assistendo alla rinascita dei loro figli. Sarebbe davvero importante che anche a livello governativo venissero date le informazioni sulle conseguenze di queste nuove abitudini di vita.
A partire dai due anni e mezzo va bene far vedere i cartoni animati ai bambini, per una decina di minuti, e con i genitori presenti che agiscono da mediatori tra mondo virtuale e reale. Solo a partire dai tre-quattro anni i bambini possono vederli da soli, sempre sotto il vigile controllo dei genitori per verificare il tipo dei filmati.
Quali azioni concrete possono fare le famiglie e le scuole per preparare i “piccolissimi” di oggi al futuro?
Offrire a ciascun bambino modelli di riferimento chiari e coerenti alla realtà del nucleo familiare e dell’ambito sociale di appartenenza.
Non meno importante, in considerazione del frequente carico d’impegni extra scolastici, sarà permettere che il bambino abbia dei momenti in cui soddisfare il proprio bisogno di giocare come desidera e che possa scegliere, in base alle proposte sostenibili per la famiglia, a quali attività ludico-sportive dedicare alcuni pomeriggi della settimana.
Roberto Carlo Russo
Roberto Carlo Russo, neuropsichiatra infantile e pediatra, è stato Direttore e docente del corso triennale di Psicomotricità presso il CSPPNI (Centro Studi di Psicomotricità Psicologia e Neuropsichiatria Infantile) di Milano dal 1972 al 2023. Ha ricoperto la carica di responsabile di una UONPIA (Unità Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) di Milano, e di responsabile del Servizio di Psicomotricità e dell’Ambulatorio di Prevenzione e Cura delle Patologie Neuropsichiche nella fascia 0-3 anni presso il Consorzio Sanitario di Zona Milano Esterno Nord-Est 1 dal 1975 al 1998. È stato docente di Clinica e Terapia Psicomotoria per il corso di laurea in Terapista della Neuro e della Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Università di Pavia dal 1999 al 2013. Professionista con ampia esperienza clinica, la sua ricerca si concentra sulle modalità d’intervento psicomotorio e psicoterapico nell’infanzia, sull’aiuto educativo e di supporto terapeutico alle figure di riferimento evolutivo.