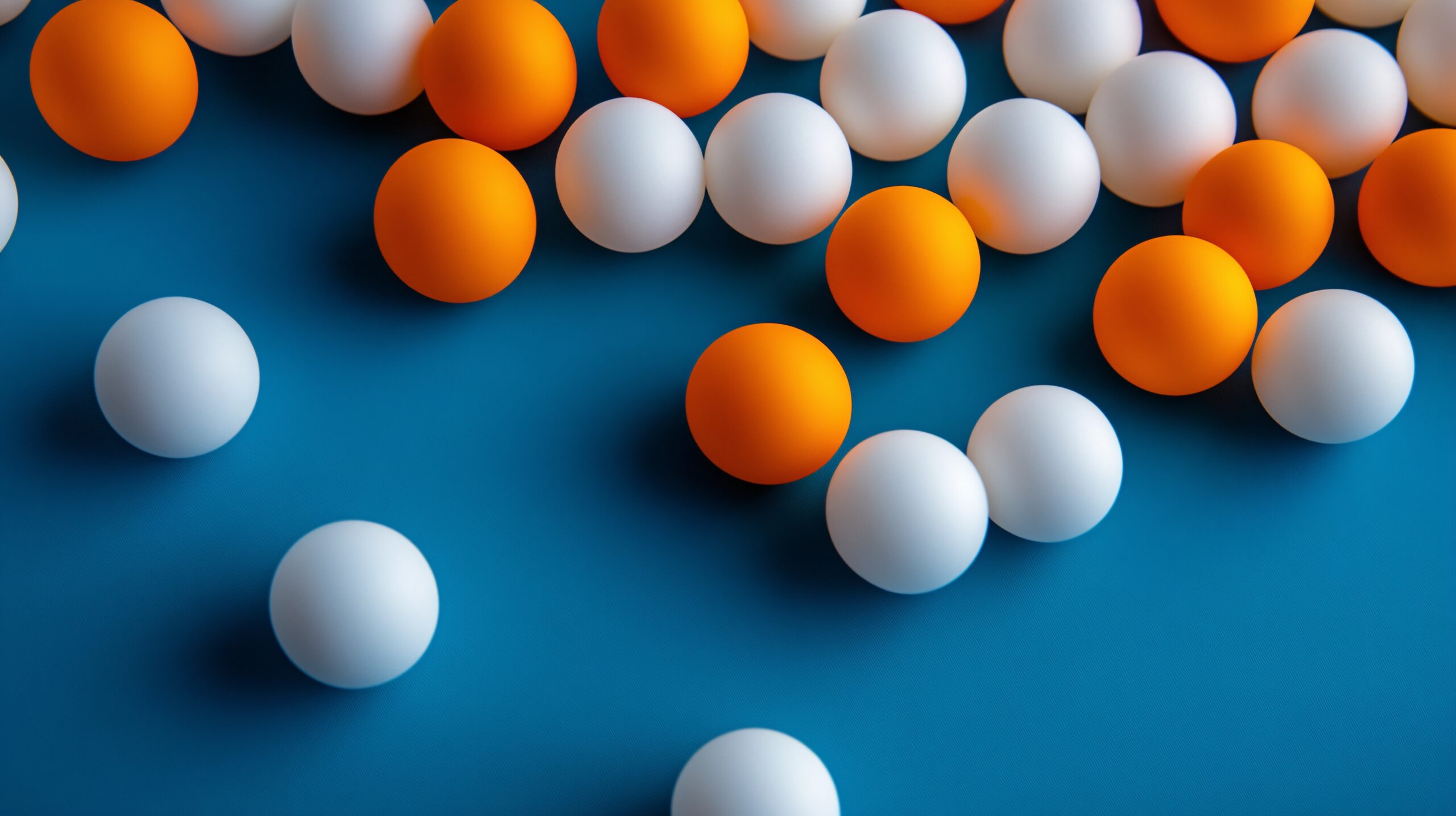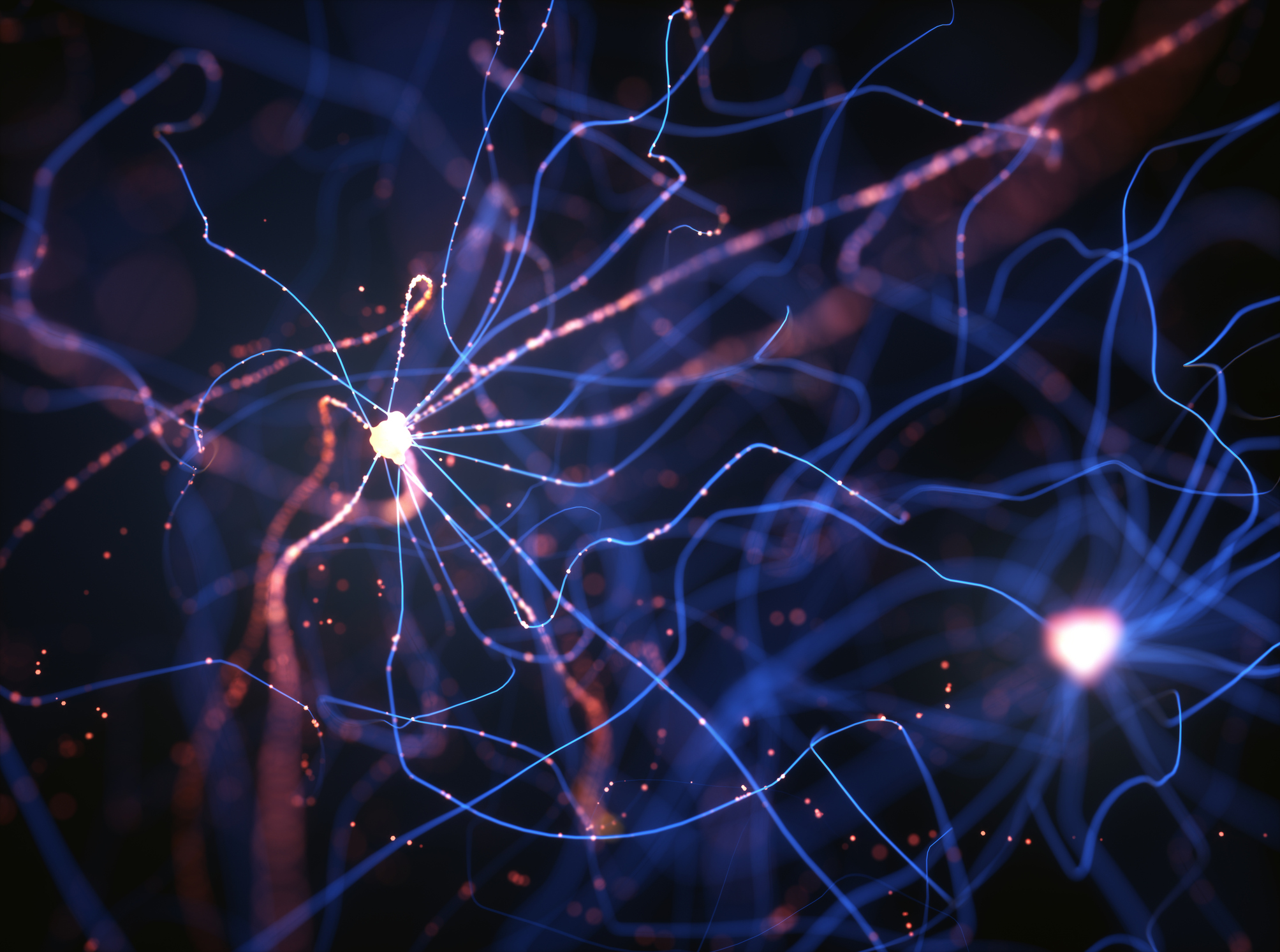Dal momento che gli studenti utilizzano sempre più gli strumenti di base che l’intelligenza artificiale offre gratis per scrivere, studiare e svolgere compiti, può essere utile dal punto di vista dell’insegnante ragionare sulla qualità dei testi prodotti. Domandiamoci allora: come scrivono ChatGPT e consimili? Possiamo declinare l’interrogativo in due modi: cercare di definire come vengono generati i contenuti e valutarne l’efficacia comunicativa, lo “stile”.
Volendo un po’ semplificare, l’AI produce testi attraverso modelli di linguaggio avanzati, chiamati LLM (Large Language Models), che sono addestrati su enormi set di dati testuali, offerti da fonti disparate come pagine web, articoli, forum e post sui social media, documenti tecnici e libri, per imparare a riconoscere schemi linguistici e a prevedere in base al contesto la sequenza di parole successive. Sono miliardi e miliardi di parole, che vengono processate in pochi secondi a fronte dei milioni e milioni di termini con cui ciascuno di noi mediamente entra in contatto nell’arco di… anni.
È evidente, l’AI non “pensa” in modo umano. I LLM operano con vocaboli assunti più come significANTI (la forma della parola) che come significATI (il concetto richiamato alla nostra mente), con buona pace del loro matrimonio indissolubile nell’unità del “segno”, teorizzato dal gran Ferdinand, che di cognome faceva de Saussure.
L’AI tritura infatti sostantivi, verbi, aggettivi e quant’altro in frammenti più piccoli, che ricordano i lessemi e che vengono chiamati token. In buona sostanza trucioli di linguaggio a granulometria definita, successivamente ricomposti su base statistica e probabilistica in “pellet” grazie all’uso di reti neurali capaci di cogliere relazioni semantiche e sintattiche complesse. Reti neurali che sono sistemi computazionali capaci di apprendimento automatico e analisi dei dati, elaborando le informazioni attraverso una struttura di nodi interconnessi, detti neuroni artificiali.
Se utilizziamo ripetutamente l’AI copywriting, possiamo notare via via difetti di cui gli applicativi stessi sembrano essere consapevoli, pur senza esserlo realmente.
Lo so, il tutto suona parecchio astratto e non immediatamente intuibile, un po’ come quando qualcuno cerca di spiegarti le regole del cricket, il pensiero di Lacan o il funzionamento di bitcoin e blockchain. Sta di fatto che, alla fine dei conti, i testi prodotti dall’AI stanno in piedi, rispondono ai meccanismi della comunicazione umana e, in senso figurato, queste benedette sequenze di pellet linguistici bruciano nel camino tanto quanto i ciocchi e i ceppi d’antica tradizione. Sì, con un po’ meno poesia e standardizzati a sacchi, qualcuno obietterà. Vero. Nulla a che fare con una bella catasta in legnaia con tronchi e tronchetti disposti a regola d’arte.
Una brutta scrittura? Proviamo a valutare, matita rossa e blu alla mano.
Se utilizziamo ripetutamente l’AI copywriting, possiamo notare via via difetti di cui gli applicativi stessi sembrano essere consapevoli, pur senza esserlo realmente. Se infatti chiedete a vari chatbot quali sono le magagne della scrittura artificiale, avrete un elenco più o meno ricorrente. In primo luogo la piattezza. I testi partoriti dai processori suonano atoni e neutri, con una voce scialba all’insegna dell’uniformità lessicale e di tono medio formale, spesso pure verboso. La ripetizione delle strutture fraseologiche confeziona una stesura monocorde e le ridondanze farcite di sinonimi, non sempre appropriati, sembrano solo voler allungare il brodo. Risultato: stessi concetti con parole diverse. Da qui una spiacevole impressione di banalità e schematismo investe i contenuti, che a loro volta possono presentare pecche come argomentazioni superficiali, peccati veniali come salti logici cangureschi, peccati mortali come le cosiddette allucinazioni, in virtù delle quali, tanto per fare un esempio, la porta dell’Inferno dantesco, dove a chi intra conviene lasciare ogne speranza, è situata a Darvaza in Turkmenistan, c/o Deserto del Karakum.
Volendo andare a caccia di altri difetti, il carniere si riempie con facilità di variegata selvaggina: dall’assenza di pensiero critico ai pregiudizi culturali, dalla mancanza di empatia alla scarsità di umorismo, ironia e originalità. In ultima analisi i testi artificiali ricordano certi mobili prodotti in serie, che, pur dotati di efficace funzionalità e ineccepibile logistica di montaggio, rendono tutte identiche le nostre case, magari con un paio di librerie Trülly, un piumone Køprilett, una cassettiera Tretirëtt e un armadio Gvardærob, senza contare le tovagliette Rûnnerlund e l’immancabile scolaposate in alluminio bucherellato Drjpperminga.

Bisogna pensare al testo prodotto dall’AI non come all’espressione di un pensiero, ma come a un oggetto da ripensare
Eppure… quando leggiamo un testo prodotto dall’AI spesso siamo sorpresi. La redazione macchinale produce infatti testi chiari, ben organizzati, con una discreta conoscenza di qualsiasi argomento, normalmente senza errori di ortografia e con una sintassi lineare. Pregi non così comuni nelle patrie scritture. Ecco perché nella didattica può essere utile per fornire un buon prototipo di partenza, una prima stesura da migliorare, personalizzare, approfondire.
In questo senso funziona meglio di tante pagine di letteratura, che la nostra scuola propone ancora più o meno consapevolmente come esemplari e che però suggeriscono modelli già molto elaborati e una materia linguistica filtrata dallo stile. Paradossalmente è proprio la carenza di stile il valore aggiunto. Bisogna allora pensare al testo prodotto dall’AI non come all’espressione di un pensiero, ma come a un oggetto. Un ramo caduto a terra, strappato dalla pianta ci può sembrare a prima vista una cosa inutile, ma se viene ripensato dall’intelligenza naturale diviene bastone, stampella, freccia, leva, torcia… ceppo da ardere e collocare in legnaia.
Ricordo che Palazzeschi nella lirica E lasciatemi divertire (L’incendiario, 1910) con futuristica preveggenza affermava, a proposito delle sequenze reificate di parole da lui definite come “piccole corbellerie” e “robe avanzate”:
“Non è vero che non voglion dire,
vogliono dire qualcosa.
Voglion dire…
come quando uno si mette a cantare
senza saper le parole.”
Un buon modo per imparare a solfeggiare.
è nato a Torino nel 1960. Insegna italiano e latino presso il liceo classico “D’Azeglio” della sua città. Dal 1995 ha insegnato al Master in Tecniche della narrazione della Scuola Holden, di cui dal 2000 al 2006 è stato anche direttore didattico. Ha pubblicato il libro Storie dell’arte (Rizzoli 2000). Dal 2007 al 2009 ha tenuto la rubrica Pianeta Scuola per il quotidiano “la Repubblica”. Per Einaudi ha pubblicato Disegnare un elefante. L’insegnante di liceo come professione (2024). Ha curato progetti e seminari di didattica della scrittura per vari istituti e società: Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Iulm di Milano, Ied di Torino, Politecnico di Torino, Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, UniCredit, Heineken, Fondazione Feltrinelli, Circolo dei Lettori e Festival Torino Spiritualità.