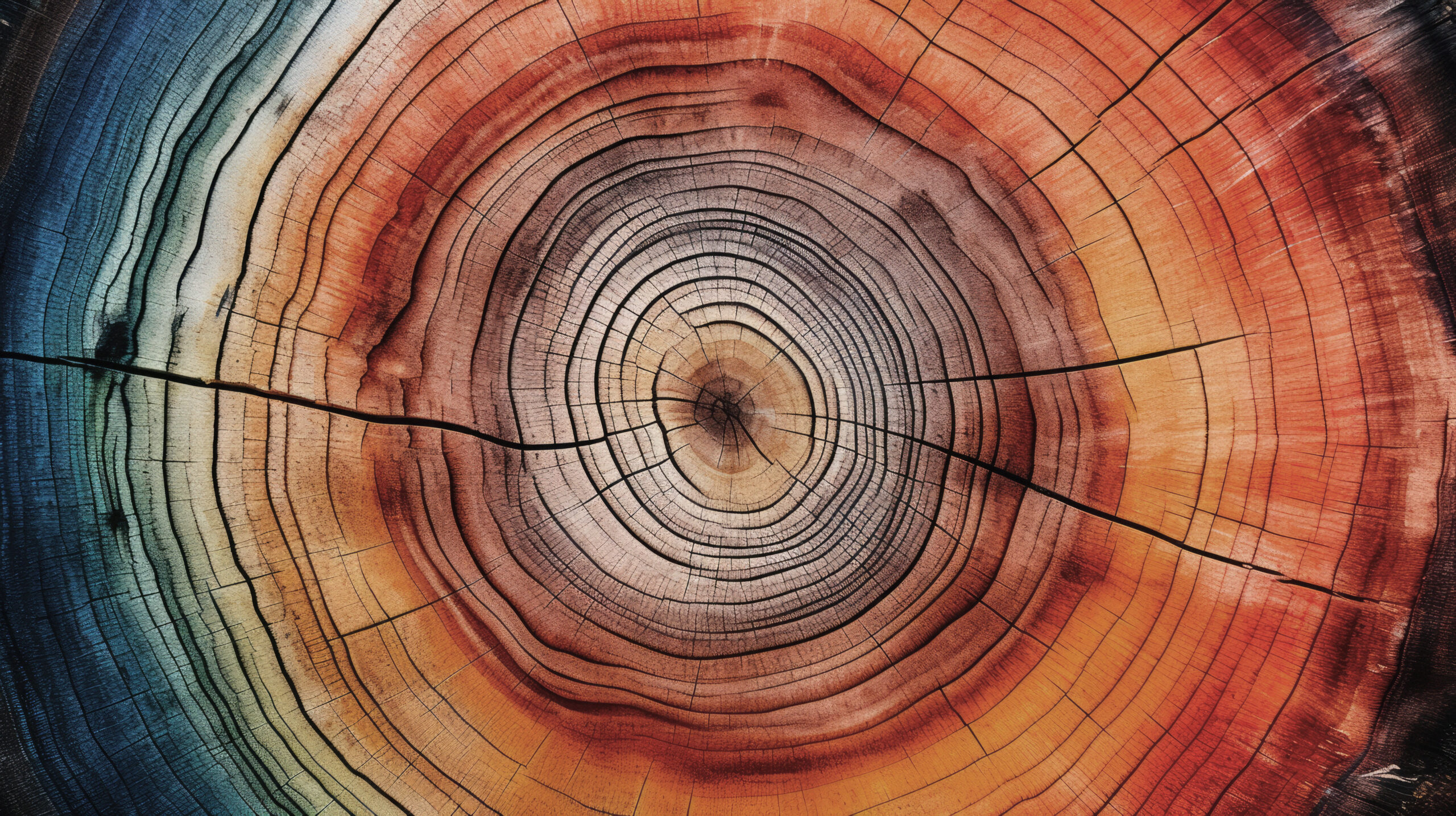Mettere l’arte al centro dei processi educativi non è un’idea nuova: era già al cuore della filosofia pedagogica del Black Mountain College, che nella North Carolina dei primi anni ’30 del Novecento proponeva un curriculum speciale. Vi si praticava l’arte non come materia di studio ma come metodo per formare cittadini nuovi, più consapevoli e maggiormente dotati di senso critico e civico.
La pedagogia del Black Mountain College, i cui docenti erano in larga misura artisti e filosofi scappati dell’Europa nazista, deve molto del suo pensiero al filosofo John Dewey, che con i suoi testi ha rivoluzionato l’approccio pedagogico, mettendo la pratica e l’esperienza al centro del processo educativo, che deve seguire i tempi del bambino e portarlo a una riflessione teorica. Quindi il momento dell’esperienza è per Dewey imprescindibile per poter poi passare alla formulazione del pensiero.

Dr. John Dewey a lavoro sulla scrivania della sua casa. © Monroe County Library Collection
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria l’educazione all’immagine è parte del curriculum, e la storia dell’arte viene studiata anche alla scuola secondaria. Si applica normalmente una lettura storico-artistica, combinata con attività pratiche che permettono la scoperta dei materiali e delle tecniche tradizionali, tipicamente legate alla pittura.
Se da un lato è importante avere le coordinate per orientarsi nella storia dell’arte, altrettanto lo è avere gli strumenti per leggere in modo critico le opere. Fin dall’infanzia è possibile costruire un approccio autonomo e diretto all’opera d’arte, rendendo chi osserva capace di muoversi nell’immagine con confidenza e libertà.
Costruire questa cassetta degli attrezzi per una fruizione critica e autonoma dell’opera è un processo che richiede allenamento e che, se ripetuto con costanza, porta frutti e risultati.
La cassetta degli attrezzi ideale contiene tante domande: sono gli strumenti che servono per leggere patrimonio culturale e opere d’arte in autonomia e senza barriere.
Proponete la visione collettiva di un’opera, chiedendo alla classe di osservare l’immagine in silenzio per qualche istante. Con una serie di domande potete guidare l’osservazione su più livelli, da un piano formale e oggettivo (forme, colori, linee, figure) fino al piano personale (quale emozione l’opera suscita, a cosa fa pensare). Partendo da qui è possibile intrecciare i punti di vista e confrontarli, per mettere in evidenza come esistano molteplici prospettive e molteplici interpretazioni.
L’opera d’arte può sbloccare memorie ed esperienze, accendendo l’immaginazione e aprendo lo sguardo verso dimensioni nuove; accade nel contesto museale e accade anche nel contesto dell’aula scolastica.
Alla presenza dell’opera – specie se si è di fronte all’originale, nello spazio del museo o nel luogo dove l’opera vive – si crea una situazione speciale: si incontrano gli sguardi, le emozioni e le esperienze di tutti i presenti, ciascuno portatore di visioni e storie personali, magari in contrasto tra loro ma tutte valide. L’osservazione collettiva può trasformarsi in un’occasione che catalizza dialoghi e scambi, in un momento che si sottrae alle regole del quotidiano, ai tempi della vita e della scuola; in questo spazio-tempo che vive a sé è possibile costruire conversazioni nuove e ricche.
La discussione, opportunamente guidata dalle educatrici/educatori e dalle docenti, genera dunque uno spazio e un tempo dove è possibile scoprire l’opera, capire il suo contesto e successivamente scambiare idee, rispondere a domande, ipotizzare narrazioni.
Ad esempio, chiedete alla classe quali elementi dell’opera attirano i loro sguardi.
Seguite le risposte e fate domande anche sui dettagli, perché la visione complessiva sia accurata e completa.
Sempre con domande “In che epoca vi sembra ambientata la scena/il ritratto/la scultura?” provate a orientare la classe sul contesto dell’opera e sull’artista. Se pensiamo a un quadro impressionista, per esempio, dopo la prima parte descrittiva, si può procedere dicendo “Qualcuno di voi ha notato che il colore è steso a piccoli tocchi, vi immaginate per quale motivo?”. Solo allora vi collegate alla storia, alla fotografia, al momento storico. Le informazioni di contesto, cucite all’osservazione libera, validano la fase precedente, dando peso alla voce della classe.

La discussione genera uno spazio e un tempo dove è possibile scoprire l’opera
Anche nella costruzione di una narrazione collettiva è possibile porre numerose domande: “Cosa stanno facendo? Cosa succede oltre all’immagine? Accadono cose che noi non vediamo? Cosa starà pensando il personaggio?”. Componendo le diverse risposte si capisce che ciascuno osserva e immagina mettendo in uso le sue inclinazioni personali e le sue esperienze; l’ascolto collettivo e l’attenzione a queste differenze insegnano le basi della coesistenza. L’esercizio della lettura dell’immagine e dell’ascolto implicano dunque il riconoscimento e l’accettazione di una pluralità di punti di vista: insegnano a riconoscere l’importanza della propria voce e della sua relazione con gli altri, nell’ottica dell’accordo di differenze teorizzato dal poeta caraibico Éduard Glissant.
Per tornare a John Dewey, possiamo perciò dire che un approccio critico alla lettura dell’opera d’arte è una buona base di partenza per la costruzione di cittadini capaci di esprimersi e di affermare le proprie convinzioni.
Ecco perché è importante affrontare l’arte a scuola in un’ottica trasformativa: non si tratta solo di mettere in ordine cronologico o di riconoscere stili, tecniche e periodi. Lo studio dell’arte e della sua storia, imparandone le modalità di lettura, di interpretazione e di restituzione fin dall’infanzia, significa imparare a leggere la complessità dell’umano e del mondo.
Per Bartolomeo ETS sviluppa progetti educativi (digitali e non) sul patrimonio culturale, esplorando nuovi metodi applicati all’educazione civica e al patrimonio. Fa parte del Gruppo di Lavoro Accessibilità 2023-2027 di ICOM Italia e dal 2010 è consulente per i Servizi Educativi della Pinault Collection a Venezia (Palazzo Grassi e Punta della Dogana).