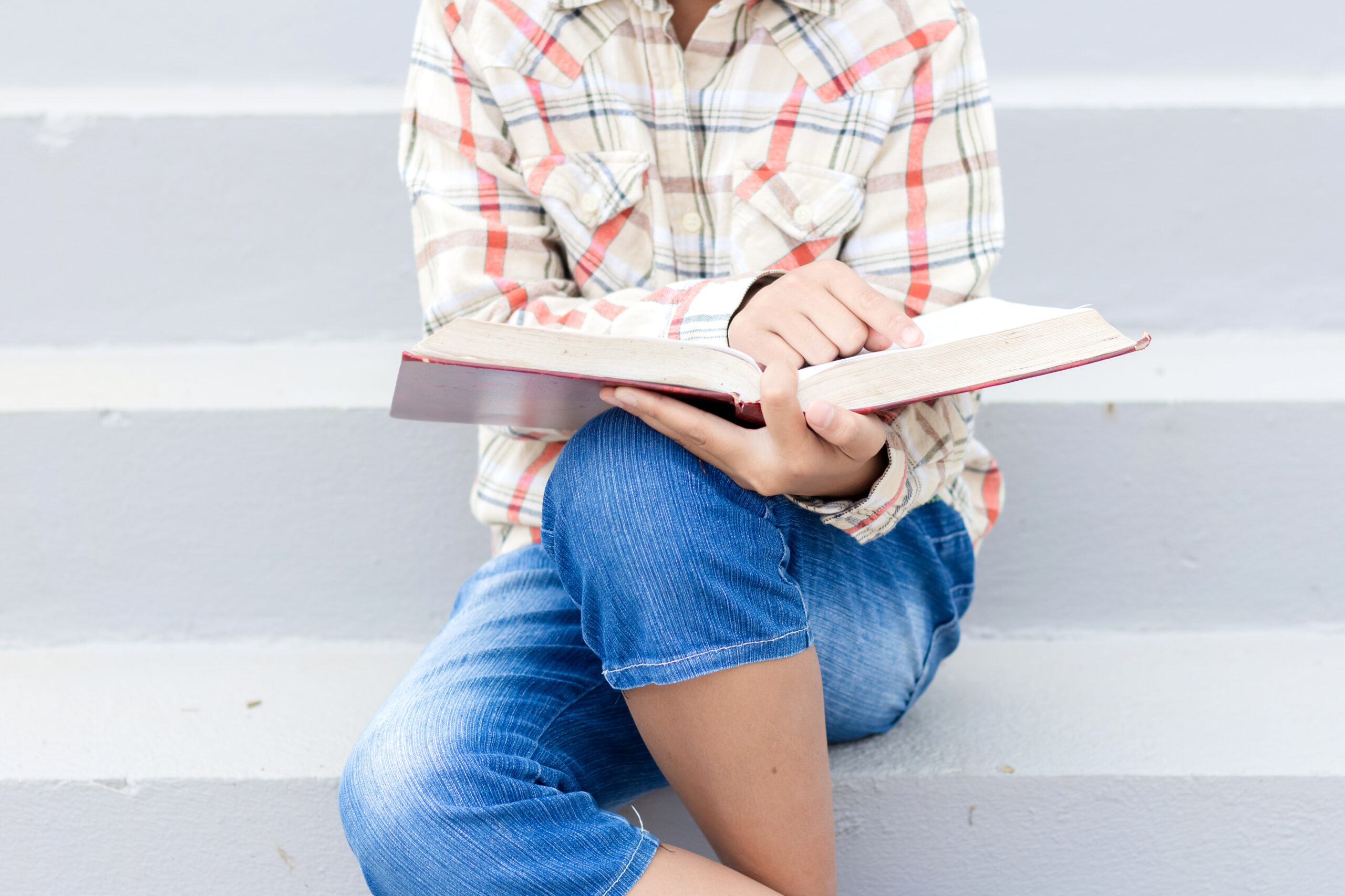In pieno accordo con lei, una bambina di nove anni di Terni, R., davanti all’affermazione “la matematica non serve a niente”, replicò che, al contrario, la matematica è dappertutto: “Ci sono gli alberi pieni di angoli, tanti modi di misurare il tempo, ci sono i rettangoli delle finestre, ci sono le spirali dei gusci delle lumache, i passi da contare mentre si cammina”.
Partendo da queste suggestioni, voglio proporvi alcune semplici pratiche di libera ricerca matematica affatto banali, che i bambini e le bambine possono mettere in atto durante le vacanze. Sono il frutto di numerose sperimentazioni ideate e realizzate da una rete di insegnanti, ma anche, e soprattutto, di idee proposte e sviluppate da bambini e bambine della scuola primaria.
Propongo una breve lista commentata di possibili attività a partire dalle quali si possono sviluppare ulteriori idee.
Una delle attività più semplici e immediate – che può essere accompagnata dalla creazione di disegni geometrici e artistici – è la caccia ai rettangoli. (Nella categoria dei rettangoli includiamo anche i quadrati, rettangoli anch’essi ma con i quattro lati uguali.)
Si può iniziare esplorando i luoghi intorno a noi, cercando rettangoli di diversa grandezza e proporzione. Facciate di palazzi, finestre, tavoli, mobili, scatole, pavimentazioni, griglie, cassetti, righe e quadrettature di quaderni. In questa esplorazione, si apre un mondo di variazioni geometriche della stessa categoria di forme.
Ritagliando dei cartoni, si può scoprire come, partendo da figure piane, si possono creare, improvvisando, figure tridimensionali complesse; si pensi alle costruzioni in equilibrio che si possono realizzare adoperando sia le carte da gioco sia le tessere del domino.
Una scoperta importante che si può fare, nel corso di questa esplorazione, è che gli angoli retti e le figure rettangolari sono una rarità nel mondo naturale. Si possono incontrare in alcuni cristalli, ma la figura del rettangolo, con le sue variazioni, è una prerogativa delle costruzioni umane.
A partire da questa ricerca si può continuare il viaggio tra le opere d’arte e scoprire come artisti quali Klee, Mondrian e altri ancora hanno usato intrecci di figure rettangolari e quadrate per comporre giochi di forme e di colore meravigliosi. Ispirandosi a questi grandi artisti si possono realizzare libere opere geometrico-artistiche; un intrecciarsi, questo, tra arte e matematica che ha dato e continua a dare preziosi frutti.

Rettangoli di campi coltivati disegnano un mosaico verde visto dall’alto.
Passando agli angoli, la ricerca si fa più complessa, ma ugualmente interessante. Come diceva R., la bambina di quarta: il mondo è pieno di angoli. Gli alberi ne sono pieni, basta osservare le variazioni di angoli tra i rami che si incontrano, tra i tronchi, gli steli e il suolo. Sono innumerevoli. Ce ne sono di ampi (ottusi), di molto stretti (acuti), raramente di retti.
Si possono scoprire angoli osservando e rilevando i movimenti del sole: si pianta un bastone a terra e, con delle cordicelle, se ne unisce la cima alla punta delle ombre che proietta con il passare del tempo. Si scoprirà che ogni filo formerà un angolo con il piano su cui il bastone è piantato, e tutti questi angoli restituiranno la misura visibile delle variazioni dell’inclinazione del sole rispetto al terreno. Tra i diversi fili si scopriranno altri angoli, il cui vertice comune è la punta del bastone, angoli la cui ampiezza varia con il variare del tempo. La misura dell’angolo che si forma tra un filo e un altro costituisce un antico modo indiretto di misurare il trascorrere del tempo prima della nascita degli orologi.
Un bel gioco di gruppo può essere quello di creare un intreccio di linee che formano numerosi angoli. Servono dello scotch di carta, un gomitolo di lana e un pavimento sufficientemente ampio. Ci si mette in cerchio, inizia il primo giocatore, che tiene il capo del filo e passa il gomitolo a un altro, che a sua volta, tenendo fermo l’estremo del filo svolto, passa il gomitolo a un altro ancora e così via, fino a che non si forma una rete intrecciata di fili, di angoli e figure geometriche di diverso tipo. A quel punto, tutti i giocatori, in accordo, poggiano a terra l’intreccio di fili tenendoli ben tesi; ognuno fissa a terra il suo angolo con un pezzetto di scotch. Si può giocare a saltare negli spazi tra i fili, a scoprire tutte le forma geometriche che si sono formate e a osservare e rilevare le differenti ampiezze degli angoli. Con righelli, fogli di carta e colori si potranno realizzare opere d’arte geometriche ispirate all’immagine casuale cui ha dato forma il gruppo di piccoli e grandi giocatori sul pavimento.
Il metro, il secondo e tutte le unità di misura che adoperiamo normalmente sono il punto di arrivo di una ricerca millenaria che ha avuto inizio nel momento in cui il genere umano ha sentito l’esigenza di quantificare la realtà. Si può giocare a essere uomini primitivi e inventare nuovi modi di misurare lo spazio e il tempo senza adoperare metri e cronometri.
Un giorno a Napoli, in una scuola primaria, inventammo un’unità di misura che chiamammo “il Ciro”, perché decidemmo di usare come riferimento l’altezza di un bambino che, appunto, si chiamava Ciro. All’inizio misuravamo adoperando il bambino stesso, ma constatammo che era scomodissimo; quindi tagliammo un bastone di legno la cui lunghezza era uguale all’altezza di Ciro, e da quel momento divenne tutto più facile. Le misure più piccole venivano misurate in “piede Ciro” e “pollice Ciro”.
La fantasia può portarci a inventare di tutto e a giocare alle origini della matematica e delle misure, ripercorrendo gli sforzi logici e creativi messi in atto dal genere umano.
Il tempo apre un altro mondo di possibilità. Si può far finta di non avere più cronometri o orologi e riscoprire o inventare modi per misurare quanto tempo si impiega, per esempio, a percorrere una certa distanza.
Tante sono le strategie possibili: adoperare un brano musicale ritmato e contare le battute basandosi sul ritmo del brano. Una bambina di una quarta di Terni, per quantificare il tempo legato alla musica, faceva una piegatura di un foglio di carta per ogni battuta, misurando il tempo in “piegature”. (Quante piegature impiega il vostro compagno per percorrere 40 Ciri di lunghezza?) Si possono adoperare, ispirandosi a Galileo Galilei, anche dei recipienti d’acqua con un rubinetto. Si inizia a misurare il tempo aprendo il rubinetto, versando l’acqua in un recipiente e chiudendo il rubinetto alla fine dell’intervallo di tempo da misurare. In questo caso il tempo si misurerà in quantità di acqua versata. Se si possiede un recipiente graduato in millilitri si può misurare il tempo in millilitri.
Un altro modo storico di misurare il tempo consiste nel far oscillare un oggetto appeso a una cordicella (di nuovo Galileo, con il suo famoso pendolo). L’oscillazione del pendolo è regolare e si può calcolare il numero di oscillazioni.
Quante piegature, quante oscillazioni o quanti millilitri gira una trottola?
Infine, come si può misurare il peso? Sempre facendo finta che non esistano i chili, e che si viva ancora agli inizi della cultura matematica, si prende un barattolo di yogurt legandogli intorno una cordicella e fissando alla cordicella un elastico. Si può rilevare il peso di un oggetto collocato nel barattolo, misurando di quanti millimetri, centimetri o “pollici Ciro” si allunga l’elastico.
È un mondo ricco di possibilità, quello in cui ci muoviamo, dove la matematica si annida in ogni angolo e ci si rivela sorprendentemente in tanti e molteplici modi.
Basta stare attenti e non smettere mai di osservare.