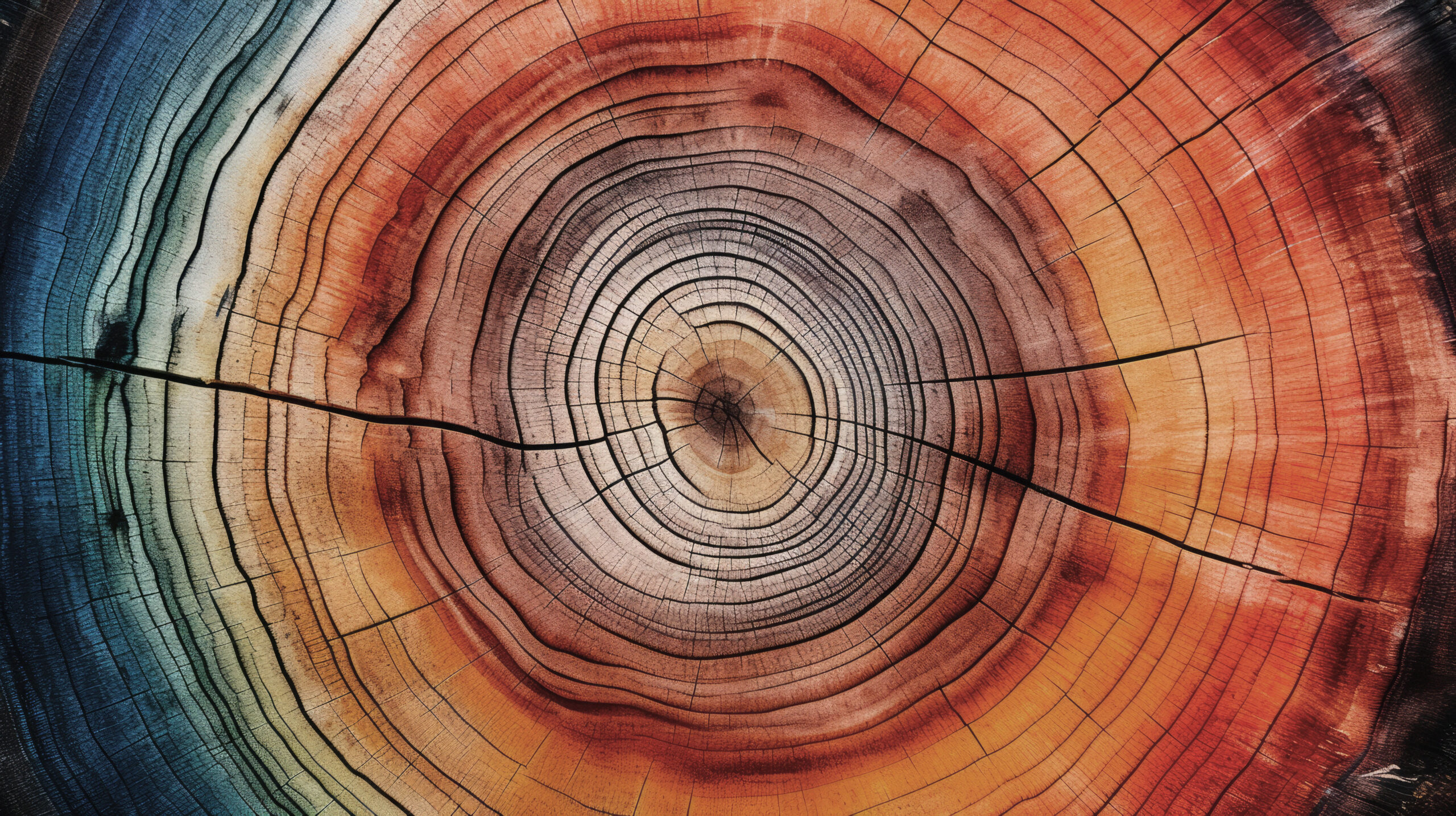Il suo romanzo d’esordio, Tutta intera, narra di una scoperta della propria identità in cui la scuola gioca un ruolo importante. Ci racconta com’è nato?
Il suo nuovo libro, Tra i bianchi di scuola, è invece un pamphlet a favore di una “educazione accogliente”. Lo dedica a tre insegnanti. Ci racconta perché questa scelta e qual è stata la sua esperienza scolastica?
Il testo ha nell’esergo tre mie insegnanti dei tre cicli obbligatori: ciò che mi hanno insegnato va ben oltre le nozioni didattiche delle loro materie. Per me “il maestro” è anche questo.
Con la parola si possono raccontare storie, con le storie si possono cambiare i pensieri delle persone.
Oltre che scrittrice, lei è anche un’attivista culturale: collabora con la scuola? In che modo?
Da quando l’ha frequentata lei, com’è cambiata la scuola italiana in questi anni? E in particolare per gli studenti con background migratorio?
Come può la scuola essere un luogo di reale interazione multiculturale?
Lei dedica un capitolo del libro al momento dell’appello: perché è così importante imparare a pronunciare anche i nomi più difficili degli studenti?
Nel libro lei invita anche – soprattutto – gli insegnanti ad adottare il giusto approccio per una scuola plurale: da dove possono partire?

Una corsa verso il futuro: piccoli studenti da ogni parte del mondo.
Quanto è importante la multietnicità degli insegnanti nella scuola del presente e del futuro?
Come sono cambiate in Italia le diverse generazioni di studenti con background migratorio, sia nei numeri sia negli atteggiamenti?
Lei ha scelto di fare della scrittura un mestiere: che valore attribuisce alla parola?
Espérance Hakuzwimana
Espérance Hakuzwimana (1991) è nata in Ruanda ed è cresciuta in provincia di Brescia. Ha studiato all’Università di Trento e poi ha frequentato la Scuola Holden a Torino, dove vive. Ha pubblicato per Einaudi (Tutta intera, 2022 e Tra i bianchi di scuola, 2024) e Mondadori (La banda del pianerottolo, 2023).
Dal 2022 è fondatrice e consulente D&I per Na.Co – Narrazioni Contaminate e nel 2025 ha fondato “Circolo Balde” un gruppo di lettura italiano per persone nere e/o afrodiscendenti in Italia.