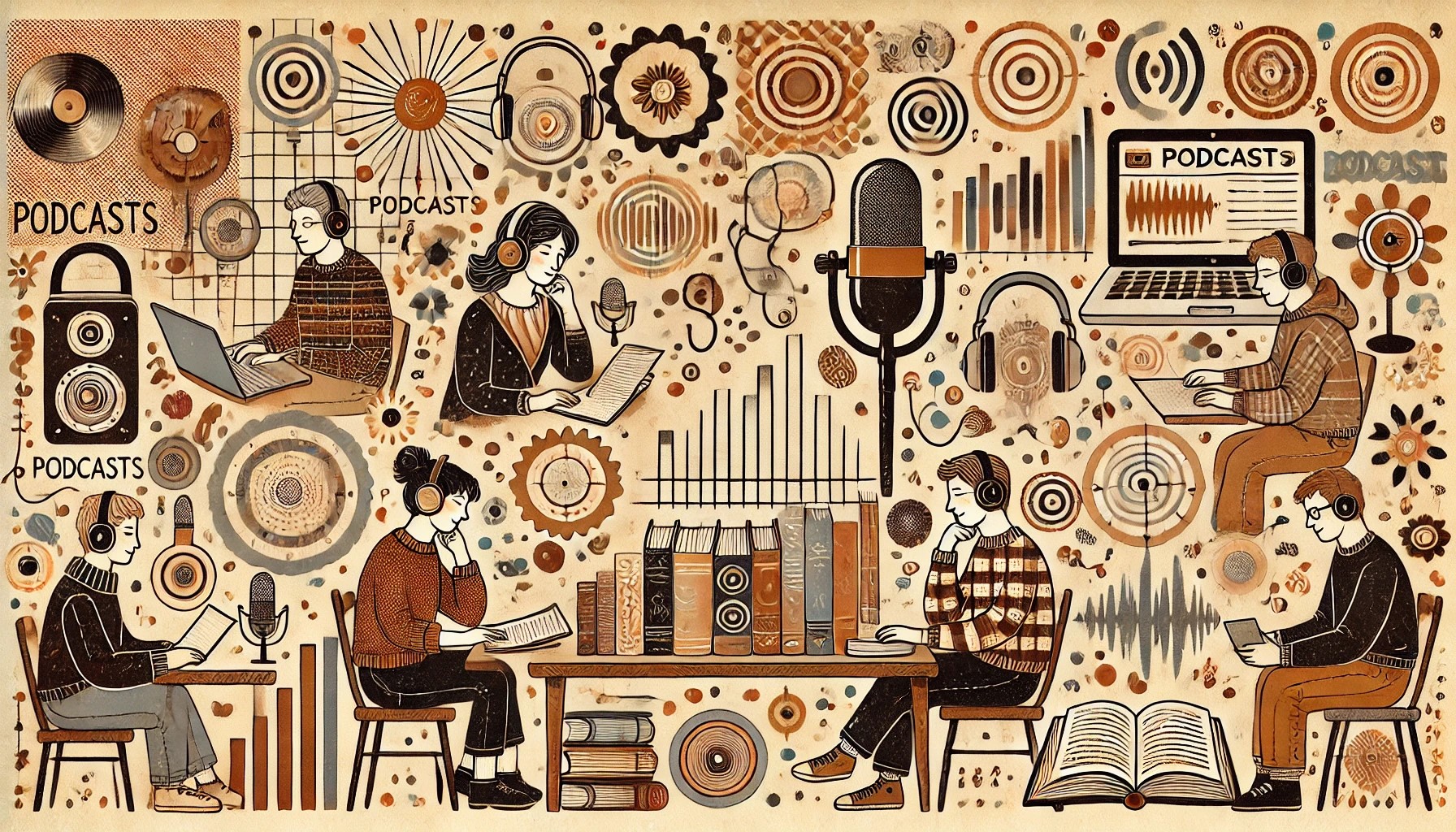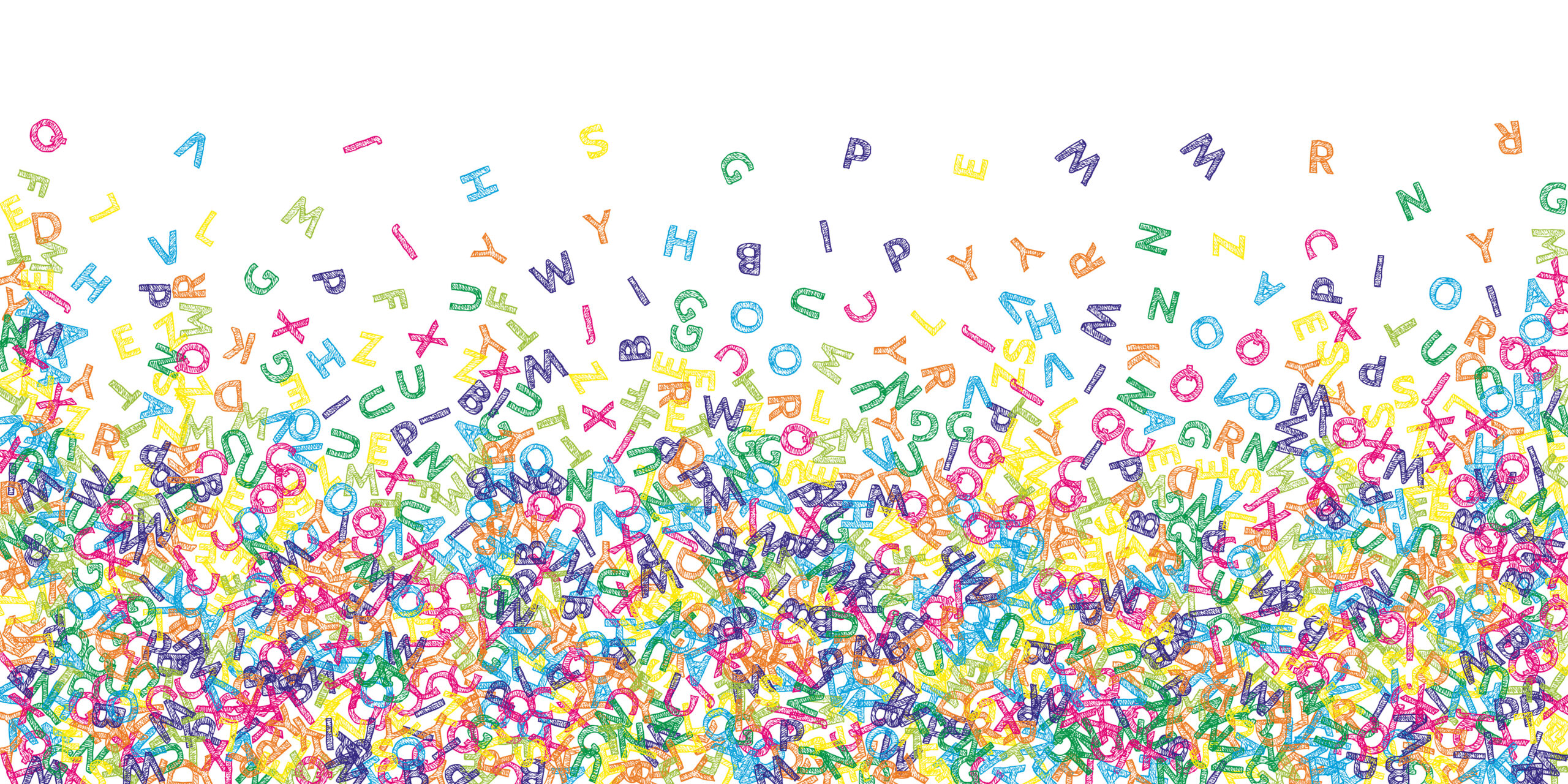Qual è la situazione demografica in Italia?
Il secondo record italiano è però la bassa natalità: nel 2024 il numero medio di figli per coppia è stato di 1,18, il numero più basso registrato dalle statistiche.
Dunque l’Italia, con la longevità della sua popolazione e con la sua bassa natalità è uno dei Paesi più invecchiati al mondo.
Si tratta di persone che vanno a scuola, lavorano, pagano le tasse e contribuiscono al benessere della nostra società. Se sottraessimo questa quota dalla popolazione attuale, che è oggi meno di 59 milioni, torneremmo a circa 52 milioni, ossia all’Italia della metà degli anni Sessanta.

La scuola è (e sempre sarà) il punto da cui ripartire per costruire il futuro.
Questi numeri fotografano un po’ quello che sta succedendo: lunga vita, bassa natalità, quindi poco peso dei giovani rispetto agli anziani, e parecchi stranieri, alcuni dei quali sono nati qua. Una situazione complessa: quali sono secondo lei le cause principali?
L’altro terzo del calo è invece dovuto al fatto che si fanno meno figli. Le ragioni sono, a mio avviso, un mancato adattamento delle politiche a ciò che vuol dire avere figli oggi.
La scuola italiana di oggi è stata costruita sulla demografia del passato, ovvero su un mondo che non esiste più.
Diventare genitori è una scelta irreversibile?
In una famosa pubblicità un tempo si diceva che un diamante era per sempre, perché tipicamente il fidanzato lo regalava alla fidanzata, si sposavano e stavano insieme per la vita. Non è andata proprio così. La storia ci dice che il vero diamante che dura per sempre oggi è un figlio o una figlia.
Quando ho iniziato a fare ricerca sembrava che l’Italia fosse immune alla possibilità che i figli nascessero al di fuori dal matrimonio. Si diceva che nascevano pochi figli perché ci si sposava tardi. Un altro record del 2024 è che il 42% dei nati sono venuti al mondo al di fuori del matrimonio. Questi dati mostrano dunque che la centralità del legame è oggi soprattutto tra i genitori e i figli, più che tra i genitori tra loro. È un fenomeno che si osserva anche negli altri Paesi.
Quando si decide di diventare genitori?
A volte si dice che le cause sono culturali, che i giovani sarebbero individualisti. Può essere, ma in tutto il mondo i giovani sono individualisti. La biologia ci insegna che in tutte le specie ci si riproduce quando le condizioni sono più favorevoli.
Un tempo si cercava di non avere figli. Oggi, che si hanno a disposizione efficaci e diffusi metodi contraccettivi, la decisione da prendere è più proattiva: tendenzialmente si fanno figli quando ce li si può permettere.
Gli stranieri inizialmente, quando arrivano, fanno più figli perché la situazione è per loro molto migliore rispetto al Paese d’origine, ma nel tempo si adattano e anche la loro natalità si adegua alla nostra.
In alcune scuole superiori del Nord Italia ci si attende una diminuzione di circa il 40% della popolazione studentesca in appena dieci anni: un dato considerato abbastanza certo, perché si tratta di bambini che non sono nati. Quali sfide o opportunità comporta una popolazione scolastica ridotta?
Una scuola a rischio di chiusura è un punto di non ritorno, perché difficilmente potrà riaprire. Lo racconta bene il film di Antonio Albanese, Un mondo a parte, ambientato in un paesino abruzzese. La scuola è il futuro di una comunità. Se chiude, anche quel futuro si chiude, insieme all’ecosistema che le ruota attorno, fatto di bambini, genitori, insegnanti, dirigenti, tecnici, bidelli, cartolai, librai, pediatri e così via. L’immigrazione interna o internazionale è quindi l’unica possibile soluzione, se non per invertire, per rallentare queste tendenze.
I dati elaborati dai demografi possono dunque aiutare a organizzare i fabbisogni del sistema scolastico.
Come sta affrontando questi cambiamenti il sistema educativo italiano? Sarebbero necessarie delle riforme?
Un dato significativo da cui partire per comprendere i problemi è il punto finale del sistema scolastico, ossia la quota dei laureati. Tra i Paesi dell’OCSE l’Italia è quella che, con la Romania, ne ha il minor numero: meno del 30% dei giovani raggiunge questo traguardo. Altri Paesi a bassa natalità, come la Corea del Sud e il Giappone, sono sul 60-70%. Ora, il 30% di laureati potrebbe anche bastare se la popolazione giovanile fosse abbondante. Essendo invece i bambini e i ragazzi così pochi, i laureati oggi sono davvero una minoranza insufficiente per un Paese moderno.
Dovremmo pensare a una scuola che, come in altri Paesi a bassa natalità, cerchi di portare avanti tutti almeno fino a 18 anni. Servirebbe forse una scuola superiore con un approccio unitario, magari con qualche materia a scelta, fino alla maggiore età. (Un problema molto italiano è la miriade di indirizzi delle scuole superiori: se un ragazzo deve per qualche motivo cambiare scuola nel corso delle superiori, per esempio per il trasferimento dei genitori, con grande probabilità non troverà lo stesso indirizzo nella scuola in cui andrà.)
Dovremmo investire di più pro capite su questi pochi ragazzi. Come appunto in Corea del Sud, dove hanno pochissimi nati, ma studiano tutti.
Noi invece abbiamo ancora un sistema basato sulla riforma Gentile. Nel 1923, quando l’aspettativa di vita era di circa 50 anni, alla fine delle elementari si stabiliva se un bambino avrebbe continuato a studiare o avrebbe fatto il cosiddetto “avviamento” alla professione. Oggi questa scelta avviene alla fine delle scuole medie, nonostante la Costituzione dica che la scuola dell’obbligo debba essere di almeno otto anni: quell’“almeno” lo abbiamo dimenticato.
Tra coloro che escono da un liceo, tre diplomati su quattro si iscrivono all’università, mentre dalle scuole professionali solo uno su quattro fa questa scelta. Per somigliare di più a un Paese come la Corea del Sud avremmo bisogno che tutti i giovani frequentassero scuole che offrono una preparazione liceale, in grado di farli arrivare all’università.
Gli studenti stranieri sono peraltro concentrati nelle zone più ricche del Paese, nel Centro-Nord, dove i loro genitori trovano lavoro. Tendono ad andare in scuole, appunto, professionali, da cui difficilmente continueranno gli studi. Se questa popolazione studentesca non è incoraggiata, considerata, istruita di più, resterà poco preparata. Che cosa potranno fare? Li abbiamo formati poco, non abbiamo dato loro la cittadinanza… Non saranno molto contenti delle loro prospettive.

Se non ci occupiamo di più dei giovani, in tanti andranno all’estero?
Sembra che stiamo sprecando tanta gioventù.
Ci sono esempi di Paesi che si sono ripresi da situazioni simili?
In Germania, che era in una situazione simile alla nostra, oggi sono arrivati a 1,5 figli per coppia: meno della Francia, ma molto meglio dell’Italia. Non è un caso che l’area d’Italia che si avvicina di più a questi tassi è Bolzano, una città che tendenzialmente imita le politiche tedesche.
Ovviamente ci vogliono molto tempo e molta pazienza. I politici che implementano buone strategie demografiche non vedranno l’esito delle loro azioni in una legislatura, anche perché i bambini hanno il “vizio” di metterci nove mesi per venire al mondo, e prima hanno bisogno di genitori che decidano di concepirli. Non bastano misure estemporanee, come i mille euro di un bonus alla nascita un anno sì e tre no, per far prendere quelle cruciali decisioni.
Qualcosa di buono lo abbiamo fatto: l’assegno unico va in una direzione positiva, mentre sugli asili nido siamo ancora indietro. Occorrono anche parecchie risorse. La Germania, quando ha intrapreso questa strada, aveva un debito pubblico che era la metà di quello italiano. E, nel nostro Paese, avere investito più sugli anziani che sui giovani ha fatto anche sì che il debito pubblico non sia diminuito.
Come cambieranno le prospettive delle nuove generazioni in un Paese con sempre meno giovani e sempre più anziani? Quali rischi e opportunità ci sono?
Pur essendo la disoccupazione oggi bassissima, la quota di persone che lavorano è la più bassa d’Europa, perché le aziende sono relativamente poche e non aumentano l’occupazione. C’è ancora l’idea che “piccolo è bello”. Nel frattempo gli altri Paesi crescono di più e i nostri giovani votano con “i piedi”, andando altrove, dove le condizioni sono più accoglienti.
Dovremmo pensare a una scuola che, come in altri Paesi a bassa natalità, cerchi di portare avanti tutti almeno fino a 18 anni.
In conclusione, qual è la ricetta di una scuola adatta alla demografia del nostro Paese?
Il cambiamento demografico oggi ci impone di ripensare il futuro della scuola, per cui si dovrebbero fare riforme coraggiose, forse costituzionali, oltre gli schieramenti e le divisioni. Anche perché gli altri Paesi stanno andando avanti, e non è più possibile dire che l’Italia è un Paese manifatturiero che non ha bisogno di laureati.
Francesco Billari
è professore di Demografia e dal novembre 2022 rettore dell’Università Bocconi di Milano, dopo aver ricoperto il ruolo di Dean for Faculty. È stato docente presso l’Università di Oxford e l’Istituto Max Planck per la ricerca demografica.
I suoi principali interessi sono la fertilità e il cambiamento familiare, il passaggio all’età adulta, l’analisi del ciclo di vita, la previsione della popolazione, la digitalizzazione e la demografia e le indagini comparative. I suoi lavori sono stati pubblicati su importanti riviste scientifiche di demografia, economia, epidemiologia e sanità pubblica, geografia, sociologia e statistica.
Con i suoi cinque figli ha sfidato le tendenze demografiche del Paese.