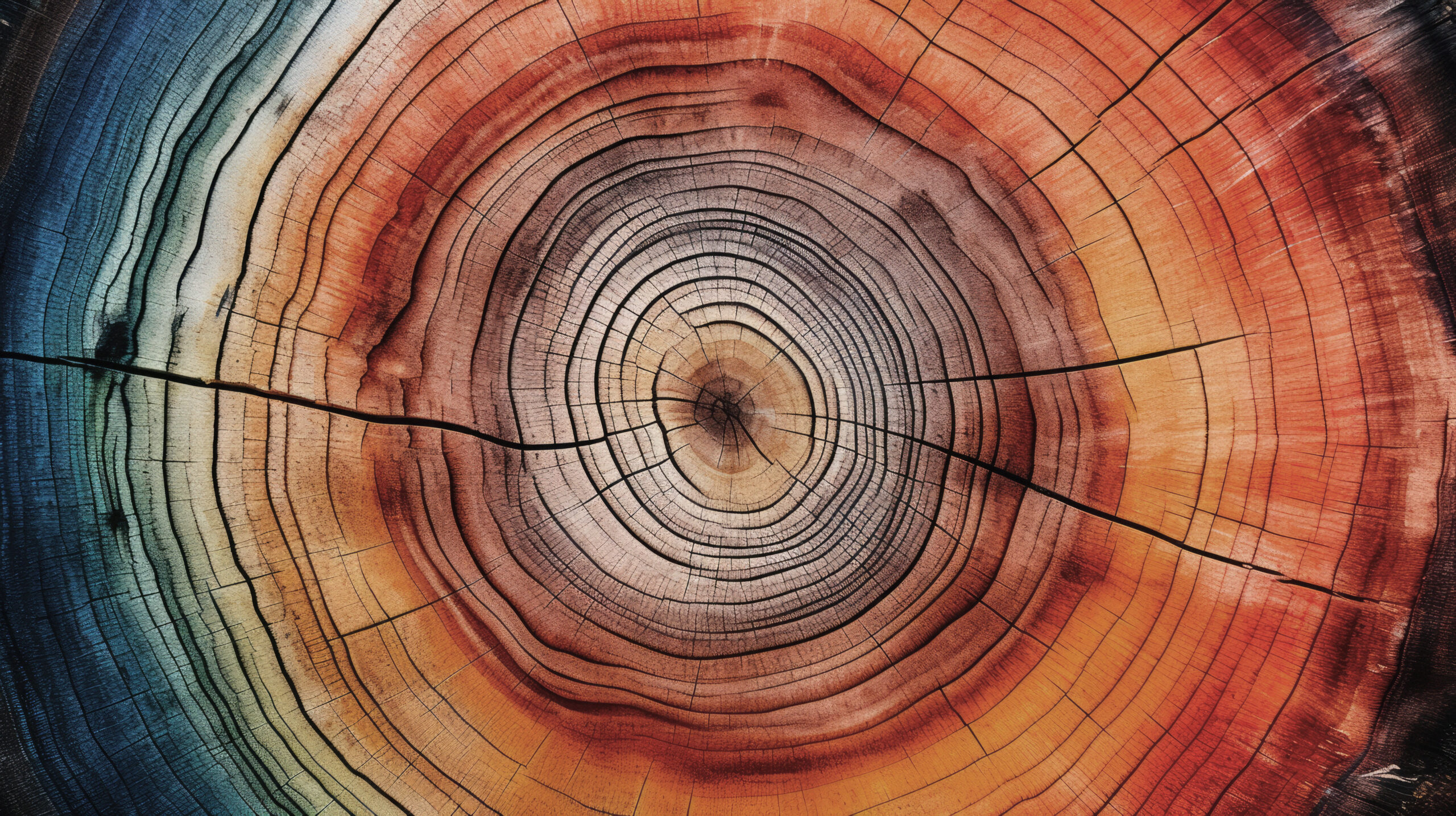Lei è scrittore, giornalista, sceneggiatore; autore di libri, articoli, racconti, giochi di ruolo, progetti didattici. Inoltre, è imprenditore, con Book on a Tree, la sua agenzia letteraria fondata a Londra. Qual è il comune denominatore del suo lavoro?
Lei leggeva molto da bambino? E quando ha iniziato a scrivere?
Che tipo di studente era a scuola?
Perché ha deciso di dedicarsi a storie per bambini e ragazzi?
Io cerco di parlare ai giovani lettori guardandoli diritto negli occhi.
I suoi libri sono tradotti e pubblicati in tutto il mondo. Quali reputa le peculiarità del mercato e dei giovani lettori in Italia rispetto ad altri Paesi?
Come si spiega la sua creatività? Come nascono le sue storie?

Come riesce a essere così produttivo in un mondo pieno di distrazioni? Si sente di dare qualche consiglio a ragazzi e adulti?
A volte non rispondo al cellulare, altre mi isolo volontariamente per rimanere concentrato. Sono molto veloce a lavorare, a patto di sapere che le prossime tre, quattro ore non sarò disturbato. Inoltre, sono poco social, anche se ovviamente un po’ devo esserlo, e poi sono curioso: usavo il computer quando nessuno lo aveva ancora, non rifiuto nulla di quello che è nuovo.
I ragazzi sono molto distratti, però la distrazione la puoi controllare. Se vuoi essere attento devi darti molto da fare: porto spesso i ragazzi a camminare nei boschi e questo funziona.
Incontra gli studenti nelle scuole? Che cosa le chiedono?
Come pensa che la scuola possa stimolare nei ragazzi la passione per la lettura di libri in modo da competere con i suoi molteplici concorrenti (social, videogame e audiovisivi in generale)?
Con Le 15 domande lei, insieme a Federico Taddia, ha realizzato un’enciclopedia cartacea per ragazzi. In un’epoca in cui le informazioni sono accessibili in un ipertesto digitale all’apparenza infinito, come e per chi avete progettato quest’opera?
Lei ha lavorato con l’intelligenza artificiale in veste di editor. Quali ritiene siano i rischi e quali le opportunità di questa tecnologia per chi scrive e per chi legge?
Come abbiamo accennato, spesso i suoi libri sono scritti in collaborazione con altri autori: come si lavora in gruppo quando si sviluppa una storia o si elabora un testo? Si può insegnare il lavoro di squadra nelle scuole?

Un’immagine del Cartino, la casa in cui Baccalario è cresciuto e che è diventato un punto d’incontro per scrittori.
Lei ha scritto un numero straordinario di libri e di saghe letterarie: ce n’è qualcuno a cui è più affezionato?
Pierdomenico Baccalario
Scrittore e giornalista, ha pubblicato romanzi, libri-gioco, racconti, giochi di ruolo, progetti didattici e umanitari e articoli specialistici. Le sue opere sono state tradotte in più di trenta lingue, e hanno venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo. È il fondatore dell’agenzia creativa e di storytelling Book on a Tree. Ha scritto insieme a Gianluca Vialli la biografia Le cose importanti e collaborato al libro La Bella Stagione, di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, diventato un docufilm con la regia di Marco Ponti, di cui Baccalario è stato uno degli sceneggiatori.