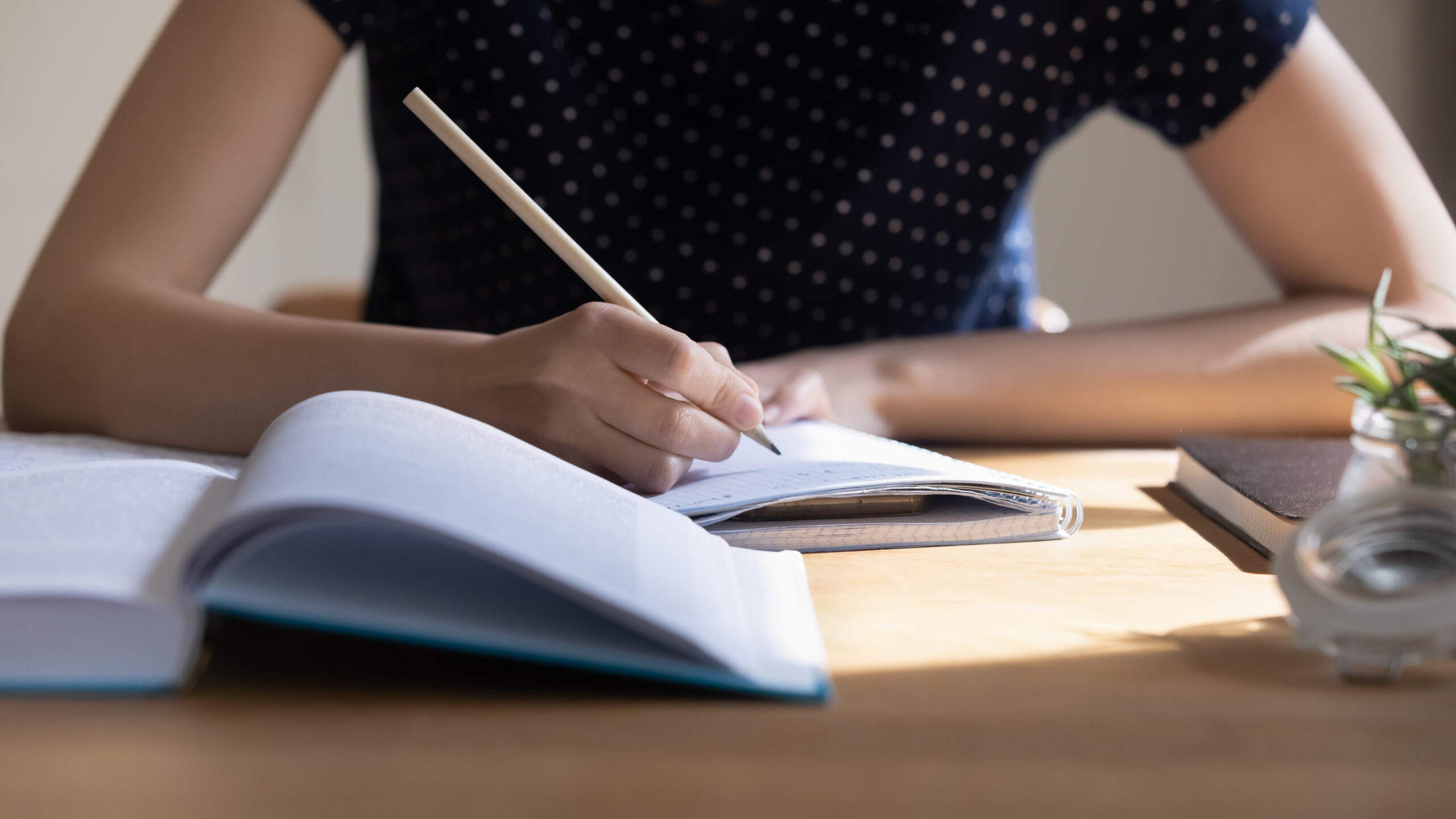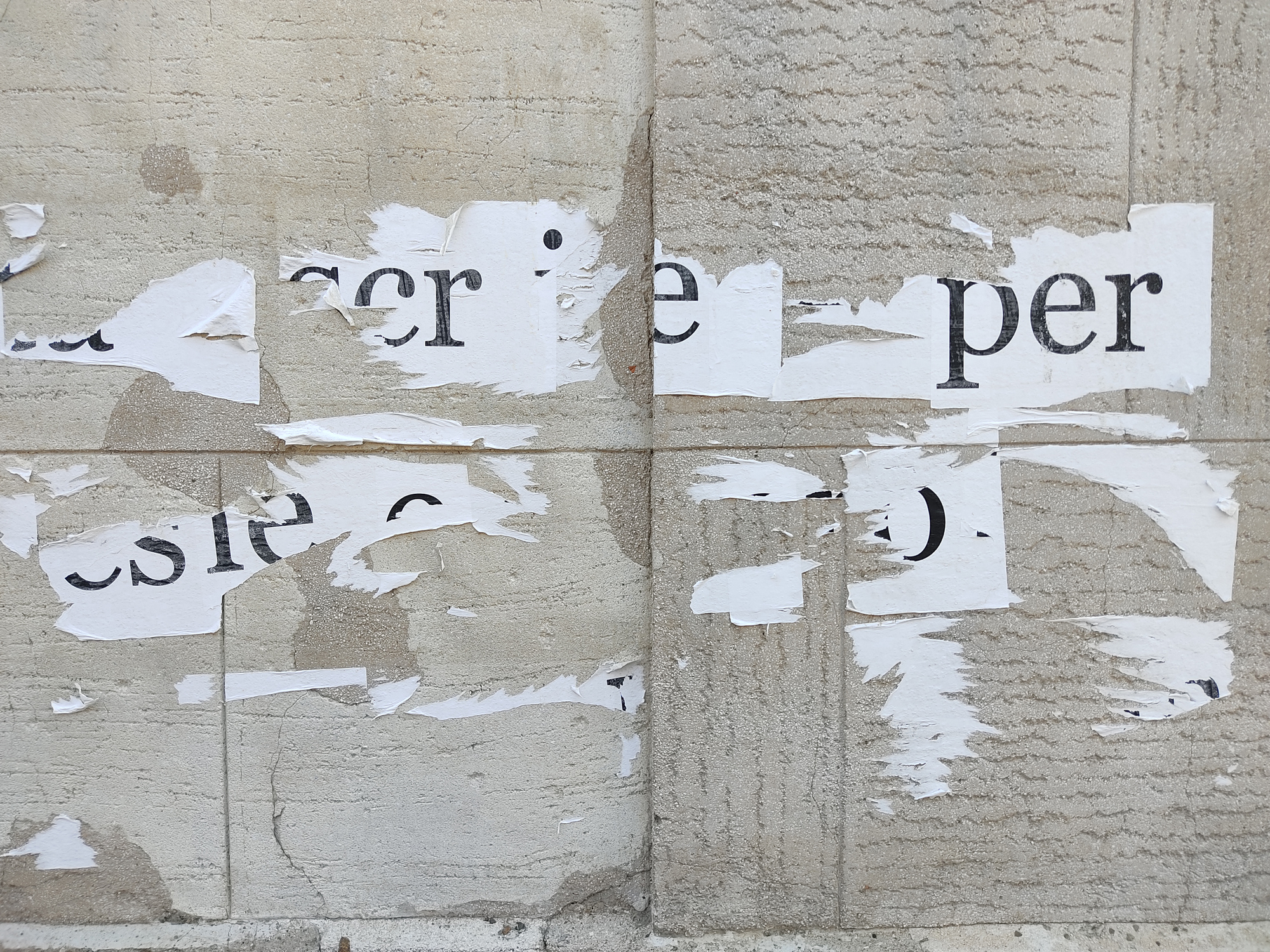Non esistono regole insindacabili nell’insegnamento del riassunto, spesso concepito come una semplice operazione pratica di scarso valore. Il libro indica le tappe faticose del riassumere: uno stretto rapporto tra lettura e scrittura, con l’ausilio della memoria episodica, il controllo della macrostruttura semantica del testo, le operazioni di riduzione secondo regole precise. Il riassunto è infatti una prova di sintesi e può avere un alto valore diagnostico nella verifica della comprensione. La prima regola è la cancellazione, cioè l’eliminazione di dettagli ridondanti non funzionali alla comprensione del testo. Si tratta per lo più di digressioni, di descrizioni accessorie. Ma questa regola, per essere efficace, non può operare per semplice eliminazione di intere frasi. Deve essere preceduta da una prima lettura e focalizzazione dell’intera macrostruttura del testo che sappia intuire le parti essenziali rispetto a quelle marginali e da una corretta sequenzializzazione del testo per cogliere il senso globale, che non è detto sia distribuito uniformemente in tutte le parti. La seconda regola è quella della generalizzazione che si apprende gradualmente nell’età evolutiva con lo sviluppo del pensiero astratto. Si tratta, ad esempio, di far uso di iperonimi, che raggruppano sotto una categoria generale più elementi individuali, come “animale” per indicare “cane”, “gatto”, “coniglio” ecc., o di utilizzare categorie meno specifiche come “episodio”, “affare”, “situazione”, o addirittura quelli che vengono definiti “iperonimi massimi” (“cosa”, “fatto” ecc.), che possono non solo riprendere nomi, ma anche interi blocchi di testo. Si può poi far uso dei cosiddetti “incapsulatori”, che, volendo, assumono anche un aspetto valutativo (con connotazione negativa o positiva), come “quella brutta vicenda”, “un omicidio brutale” oppure “una bella pagina” ecc. La terza regola è la costruzione attraverso la quale il lettore o ascoltatore ricorre a un “copione” (o frame, come “andare in aeroporto”, “festeggiare un compleanno” ecc.) per inquadrare l’intero atto globale in cui può essere presentato il testo. È un’operazione che presenta un certo margine di “soggettività”, e quindi di arbitrarietà, perché implica fare inferenze per definire la situazione, ma può anche risultare una buona guida alla produzione di un riassunto efficace.