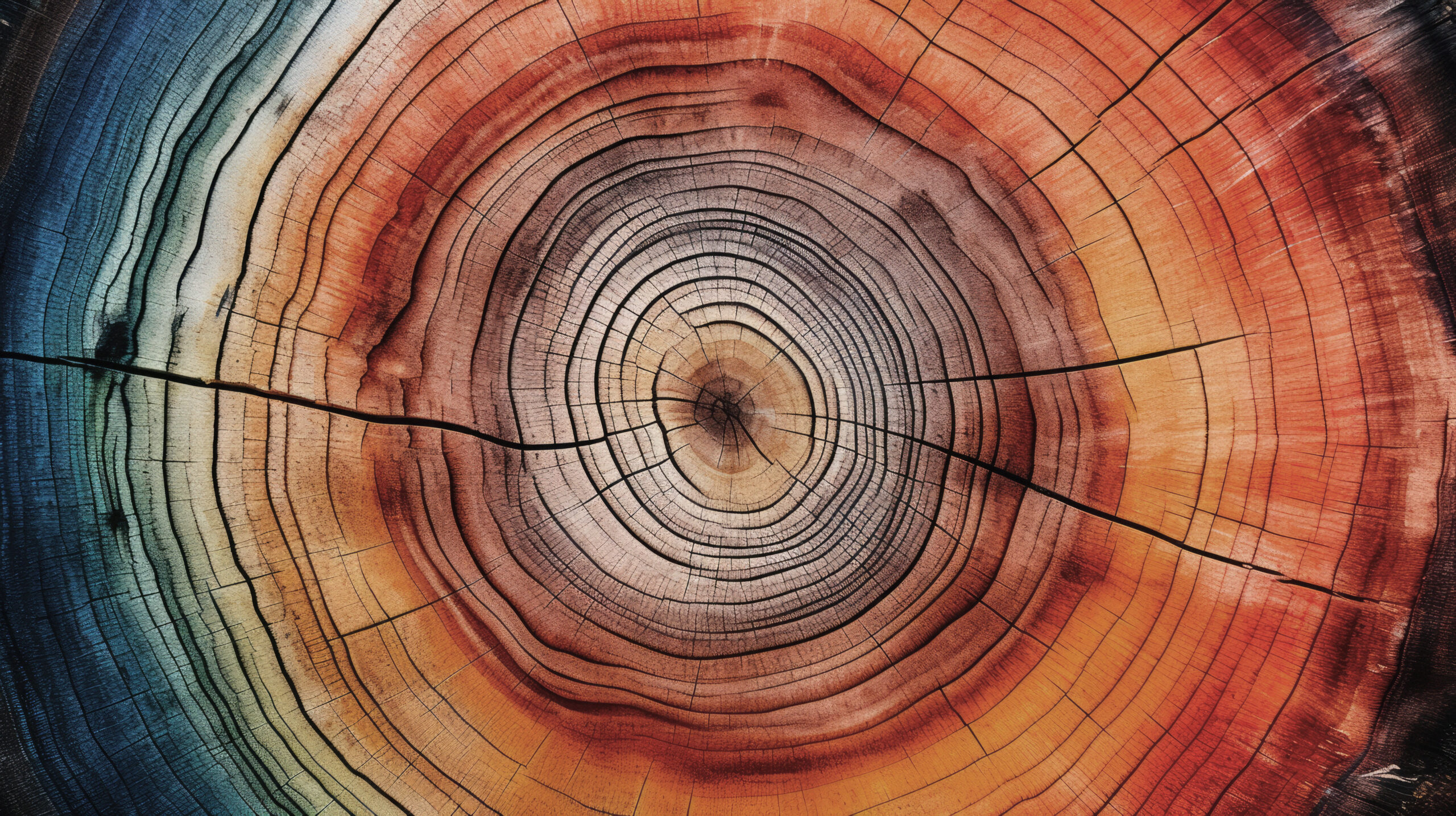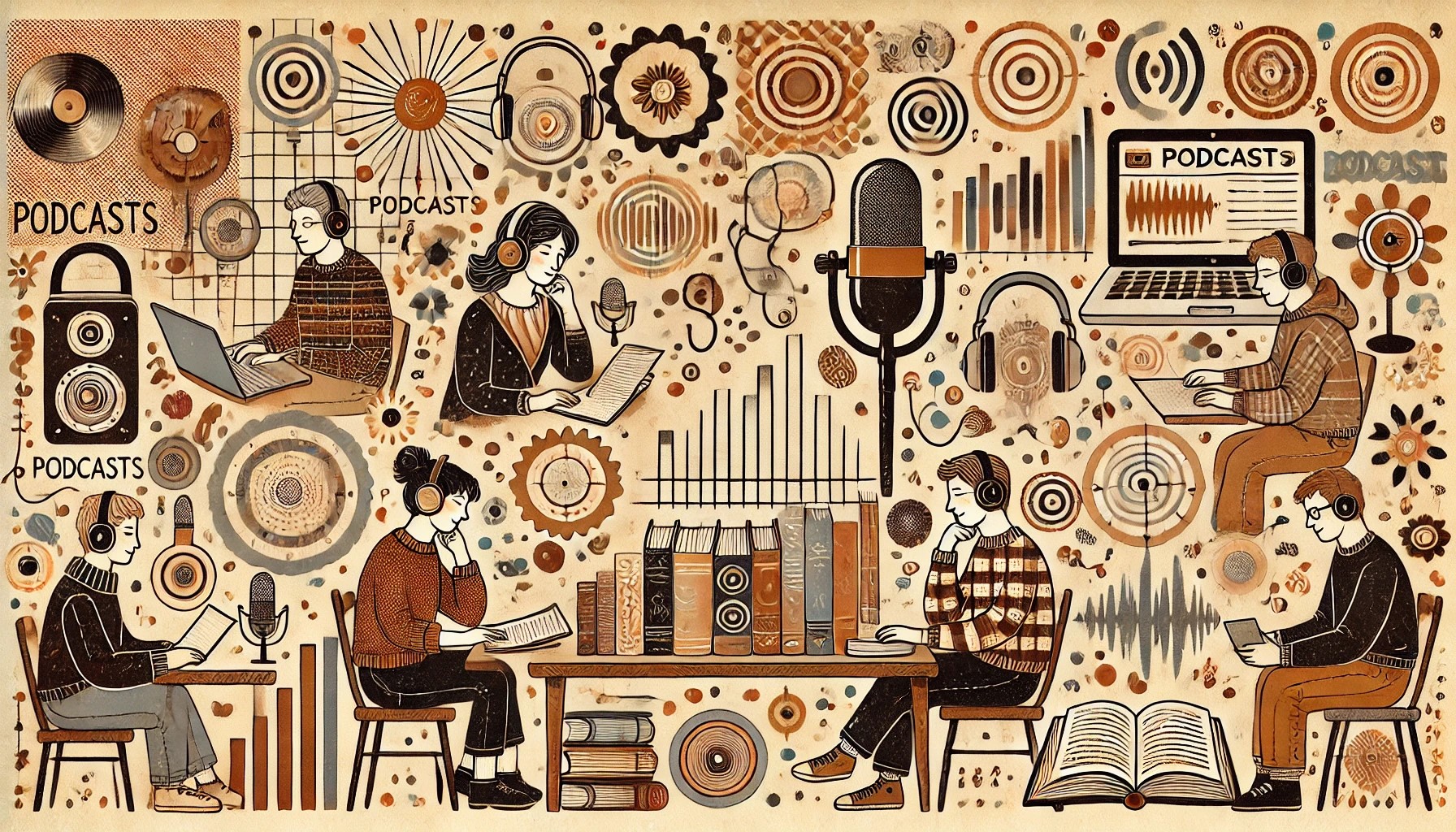Lei ha appena pubblicato Rimembri ancora (il Mulino, Bologna 2024), un libro molto stimolante il cui argomento è chiaramente riportato nel sottotitolo: “Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola”. Ci racconta come è nato questo libro?
C’è una formazione come lettori che tutti abbiamo anche se non ce ne ricordiamo, e che forse è ancora più radicata di quella dei romanzi: è legata alla poesia e rimanda a un canone scolastico, che con l’età adulta è divenuto inerte. Ma se tu lo riattivi anche solo con un verso, questo rapporto si schiude immediatamente a un orizzonte di ricordi molto articolato. L’idea del libro si è sviluppata dialogando con l’editore, che mi aveva chiesto un testo dedicato al racconto della letteratura. Così ho pensato a un’opera sulla poesia che non fosse né un’antologia, né un canone personale, ma offrisse l’occasione per una sorta di ripasso generale producendo sorprese e occasioni di riappropriazione di sé e della propria memoria.
Quando è nata la sua passione per la letteratura e soprattutto per la poesia? C’è un’opera, un autore o un insegnante in particolare a cui la fa risalire?
Da quando ho coscienza ho sempre avuto un rapporto molto forte con tutto ciò che è narrativo. Le mie primissime passioni sono state il disegno e il fumetto. Da lettore di Topolino e da aspirante disegnatore, tra gli otto e i dieci anni ho capito che cosa significasse produrre storie con parole e immagini. Presto sono poi arrivati i classici latini e greci. In primis l’adattamento dell’Odissea e i racconti degli dei dell’Olimpo, e i libri della Fabbri che raccontavano le tragedie di Shakespeare e Molière. Mi affascinavano perché erano libri illustrati, in cui sentivo una dimensione di familiarità, seppur misteriosa, che non mi ha mai più abbandonato.
La poesia è ancora in grado di emozionarci come un tempo?
Non voglio essere blasfemo, però non è detto che la poesia emozionasse sempre nel passato. La poesia può determinare come non determinare un incontro, una rivelazione: molto è nelle mani del docente che prova a contagiare con la propria passione gli studenti. Qualche volta basta anche una semplice sequenza di parole per destare l’attenzione, però non è detto che questo accada. Il punto è che senza la scuola certe cose non le avresti mai incontrate. È difficile imbattersi nell’Infinito di Leopardi o nel Cinque maggio di Manzoni fuori della scuola. Non credo che la scuola debba essere prescrittiva o autoritaria, ma semplicemente penso che un programma scolastico sia composto di occasioni che, se possono sembrare un po’ forzate, hanno un valore perché non si darebbero altrove.

© Simone Crespiatico – Istock
Secondo lei qual è l’età più adatta per lo studio della poesia a scuola? Ed è utile impararla a memoria?
Nella tradizione millenaria di scrittura poetica prevalgono i poeti giovani o molto giovani, Rimbaud su tutti. Questo dimostra la possibilità di sentire, produrre, ricevere poesia fin da ragazzi. Nella scuola primaria hai una capacità di accostarti a un testo in modo ludico, che si perde presto. È l’occasione più decisiva nel rapporto con il significante, con tutto quello che è suono e gioco della parola, anche prescindendo dal senso. Senza saperlo, il bambino è un bravissimo lettore di poesie d’avanguardia: i versi magari non dicono niente ma illuminano, esaltano, fanno ridere. Se pensiamo all’adolescenza, credo che certi turbamenti, certe rivelazioni del mondo li puoi cogliere con una grande intensità se ti disponi all’ascolto della poesia. Quello che può mancarti, soprattutto affrontando il tipo di poesia dominante a scuola, è il vissuto, l’esperienza dolorosa che ne illumina le pieghe. A un certo punto, da adulto, se ne coglie con maggiore profondità il senso. Non esiste insomma un’età privilegiata per la poesia, ma esiste una possibilità di essere lettori, sempre, e questo purtroppo spesso lo dimentichiamo. Detto ciò, imparare una poesia a memoria è prima di tutto un utile modo per allenare una facoltà che abbiamo e che sottovalutiamo. Inoltre, una poesia che resta in te e non ti lascia più credo rappresenti una ricchezza interiore. L’ho capito meglio proprio con le numerose reazioni che sto ricevendo per questo libro.
C’è un consiglio che darebbe a un insegnante per affrontare lo studio della poesia in classe?
Il rischio è sempre quello di soffocare il testo con le premesse, gli apparati, le considerazioni tecniche e stilistiche. È come se tu facessi una sorta di preparazione al tuffo senza mai tuffarti. Ti spiegano come si fa, però non c’è l’acqua, e allora dove ti tuffi? A scuola si rischia spesso, con le migliori intenzioni, di preparare molto ai tuffi senza poi consentire di farli. Esiste un altro approccio: prima di tutto leggere ad alta voce senza premesse, e vedere che tipo di reazione ottieni. Magari solo bocche aperte oppure sguardi interdetti, ma questa prima reazione è ciò su cui innescare un discorso paratestuale di analisi. Il contatto diretto con il testo può generare osservazioni che forse possono essere ingenue, ma da cui comunque puoi partire per costruire una coscienza di lettura.
Come si fa a rendere i poeti del passato attuali e accessibili? Crede che la cultura pop possa aiutare in tal senso, grazie a film, serie televisive e musica?
Se io accosto una canzone contemporanea a un testo poetico della tradizione non li sto mettendo sullo stesso piano come pensa chi è scollato dal contemporaneo: sto semplicemente creando una pista, un ponte. Prendo una canzone che parla di quell’argomento e poi le accosto una poesia; poi alla poesia accosto un’opera d’arte e una clip di un film: tutto funziona perché si crea una specie di galassia di riferimenti che aiutano a cogliere con più nitore il senso della poesia. In un liceo, i ragazzi hanno autonomamente accostato canzoni ad alcune delle poesie di cui parlo nel libro, a volte in modo illuminante. Non è una questione di gerarchia, ma di prossimità, innanzitutto emotiva. Quando parli del male di vivere devi chiederti dove lo incontrano oggi gli studenti. Ci sono riferimenti che risultano oscuri per l’insegnante, ma sono parte della vita quotidiana dei ragazzi. Non sarei mai troppo perentorio nel pensare che la poesia debba o possa parlare da sola.
Tutto funziona perché si crea una specie di galassia di riferimenti che aiutano a cogliere con più nitore il senso della poesia
Nel libro lei dedica un capitolo all’evoluzione delle antologie scolastiche di poesia: alcuni autori sono scomparsi, altri resistono. Quali potrebbero essere i criteri migliori per elaborare un canone oggi?
L’antologia del biennio delle superiori offre spunti fecondi perché sganciata dalle necessità dello studio cronologico, anche se il rischio sono la bulimia e la confusione. Ma è proprio nel momento in cui non studi la poesia in termini ordinati che può avvenire una scoperta, come quando in gelateria assaggi gusti diversi. Affrontare un po’ di poesia contemporanea, l’epica, un Carducci o un Pascoli anche solo a campione è il modo per prendere dimestichezza con la varietà dei generi, per questo il biennio delle superiori è decisivo. Molti insegnanti creano le loro antologie alternative: non seguono nemmeno un libro di testo. Può essere un po’ scioccante, ma è un metodo più utile, almeno in sede preliminare, piuttosto che iniziare dalle origini della poesia. Magari una poesia di Kavafis, Neruda, Hikmet o Szymborska ti colpisce e ti consente di avviare un discorso più ampio sulla poesia e sulla sua funzione. Diciamo quindi che assaggiare più gusti allena il palato del lettore di poesia, anzi del non lettore di poesia, che è un po’ amorfo e quindi ha un grande bisogno di sperimentare.
Lei incontra spesso studenti e insegnanti. Qual è lo stato di salute della scuola oggi secondo lei?
Nonostante l’indifferenza generale o le polemiche pubbliche, la scuola è un cantiere sempre aperto, da settembre a giugno, dal valore inestimabile, ed è curioso che tanti adulti non lo capiscano. È una ricchezza per la società, e noi la trascuriamo: facciamo sempre discorsi astratti su cosa la scuola dovrebbe fare, ma intanto la scuola fa, non è mai in uno stato inerziale, perché non sono inerti i suoi fruitori. Tra scuola e famiglia ci sono interferenze, che spesso sono catastrofiche perché esautorano gli insegnanti, ma manca il dialogo che sarebbe invece decisivo. I docenti sono continuamente vessati e costretti a ripensare i metodi, spesso anche in una chiave aziendalista. Detto ciò, e nonostante le poche risorse a disposizione e lo scoramento della classe degli insegnanti, sono convinto che la scuola rappresenti uno spazio di estrema vitalità.
Paolo Di Paolo
Finalista al Premio Strega 2024 con Romanzo senza umani, è autore tra l’altro di Mandami tanta vita (2013, Premio Salerno Libro d’Europa, Premio Fiesole Narrativa e finalista Premio Strega), Una storia quasi solo d’amore (2016), Lontano dagli occhi (2019, Premio Viareggio Rèpaci), tutti editi da Feltrinelli e tradotti in diverse lingue europee. Scrive su “la Repubblica” e conduce su Rai Radio 3 la trasmissione sulla lingua italiana La lingua batte. Rimembri ancora è uscito per il Mulino nel 2024.