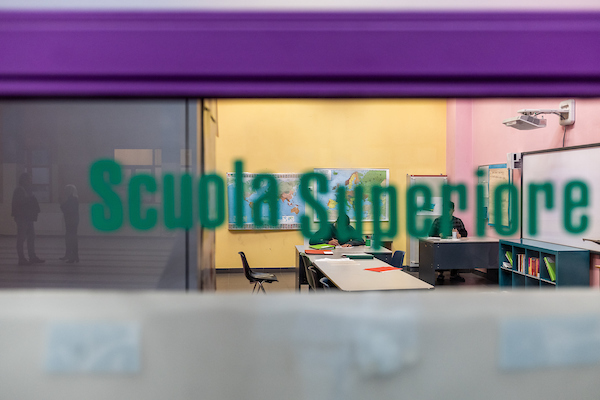Qual è stata la sua formazione e dove insegna?
Dopo aver studiato marketing all’università, ho lavorato per un breve periodo in azienda. Tuttavia, la sera tornavo a casa insoddisfatto: il mondo aziendale, fatto di numeri e orientato alla prestazione, mi stava stretto. Avendo avuto molti esempi in famiglia, conoscevo bene il mestiere dell’insegnamento e ho capito che quella poteva essere la mia strada. Così, cinque anni fa, a ventinove anni, ho ripreso la mia formazione, conseguendo una laurea in Lettere e frequentando, in seguito, il Tirocinio Formativo Attivo per diventare insegnante di sostegno.
Il TFA è stato un percorso illuminante: mi ha permesso di scoprire come la scuola fosse cambiata da quando ero studente, come avesse preso coscienza di realtà che fino a vent’anni fa erano poco considerate: le fragilità individuali degli studenti, le difficoltà socioculturali, le barriere linguistiche. Ho imparato che fare scuola oggi significa affrontare tante sfide contemporaneamente, che ogni ragazzo, con o senza una fragilità certificata, deve essere seguito in maniera personalizzata. Soprattutto, ho compreso che insegnare significa preparare i ragazzi non tanto e non solo al lavoro, ma a vivere, a diventare uomini e donne a tutto tondo.
Dopo la formazione, ho iniziato come insegnante di sostegno in una scuola secondaria di primo grado di un quartiere periferico di Roma. Poi mi sono spostato nello stesso ciclo scolastico nella mia provincia, l’Avellinese, dove lavoro attualmente.
Il TFA è stato un percorso illuminante: mi ha permesso di scoprire come la scuola fosse cambiata da quando ero studente, come avesse preso coscienza di realtà che fino a vent’anni fa erano poco considerate: le fragilità individuali degli studenti, le difficoltà socioculturali, le barriere linguistiche. Ho imparato che fare scuola oggi significa affrontare tante sfide contemporaneamente, che ogni ragazzo, con o senza una fragilità certificata, deve essere seguito in maniera personalizzata. Soprattutto, ho compreso che insegnare significa preparare i ragazzi non tanto e non solo al lavoro, ma a vivere, a diventare uomini e donne a tutto tondo.
Dopo la formazione, ho iniziato come insegnante di sostegno in una scuola secondaria di primo grado di un quartiere periferico di Roma. Poi mi sono spostato nello stesso ciclo scolastico nella mia provincia, l’Avellinese, dove lavoro attualmente.
Quali sono le specificità del suo lavoro di insegnante di sostegno?
Spesso l’insegnante di sostegno viene percepito come una figura dedicata esclusivamente al ragazzo o alla ragazza a cui è assegnato. In realtà, è un ruolo che riguarda l’intera classe: ha il compito di facilitare le relazioni tra i compagni e i rapporti tra studenti e insegnanti di disciplina.
In questo senso, l’insegnante di sostegno occupa una posizione privilegiata, perché trascorre molte ore con la stessa classe: da un minimo di nove fino a diciotto, molto di più persino di un docente di lettere. Questo permette di intercettare dinamiche che i colleghi, soprattutto quando sono presenti in quella classe per poche ore, non possono cogliere. Quando si osservano gli studenti in contesti diversi e con docenti differenti, si imparano a conoscere a fondo: a volte basta uno sguardo o un’espressione per riconoscere l’inizio di una tensione o il seme di un comportamento problematico. I ragazzi, infatti, si comportano in maniera molto diversa a seconda della materia e dell’insegnante. Tra i nostri compiti c’è quello di aiutarli a mantenere coerenza e autocontrollo in qualsiasi situazione e, al tempo stesso, fornire ai colleghi informazioni sul comportamento generale degli studenti, non solo di quelli che seguiamo più da vicino, così da offrire ulteriori elementi utili al loro lavoro.
In questo senso, l’insegnante di sostegno occupa una posizione privilegiata, perché trascorre molte ore con la stessa classe: da un minimo di nove fino a diciotto, molto di più persino di un docente di lettere. Questo permette di intercettare dinamiche che i colleghi, soprattutto quando sono presenti in quella classe per poche ore, non possono cogliere. Quando si osservano gli studenti in contesti diversi e con docenti differenti, si imparano a conoscere a fondo: a volte basta uno sguardo o un’espressione per riconoscere l’inizio di una tensione o il seme di un comportamento problematico. I ragazzi, infatti, si comportano in maniera molto diversa a seconda della materia e dell’insegnante. Tra i nostri compiti c’è quello di aiutarli a mantenere coerenza e autocontrollo in qualsiasi situazione e, al tempo stesso, fornire ai colleghi informazioni sul comportamento generale degli studenti, non solo di quelli che seguiamo più da vicino, così da offrire ulteriori elementi utili al loro lavoro.
Quali sono le modalità didattiche che preferisce?
Un metodo che trovo particolarmente utile è la gamification: sono infatti convinto che il gioco sia un canale privilegiato per l’apprendimento e, anche grazie alla mia giovane età, quello dei videogiochi è un linguaggio che conosco bene e che frequento.
Spesso, per esempio, preparo per i miei studenti piccoli giochi su Kahoot!, una piattaforma didattica diffusa nelle scuole. Possono essere quiz o altre attività in cui i ragazzi possono avvicinarsi alle discipline attraverso il linguaggio videoludico che riconoscono e apprezzano. In questo modo li vedo imparare più velocemente e con meno sforzo. Partecipano con entusiasmo, si sentono autorizzati a provare, anche a sbagliare, senza l’ansia della risposta giusta. Il fatto di condividere un linguaggio, quello dei videogiochi, con il docente cementa il rapporto di fiducia e permette loro di sentirsi compresi, incentivandone l’apertura e l’impegno.
L’unico limite è che, non essendo prove valutate, a volte gli studenti danno meno peso a queste attività.
La valutazione è un tema cruciale che può motivare ma anche avere l’effetto contrario: capita che alunni con difficoltà particolari si impegnino con costanza e poi, di fronte a un voto poco gratificante, perdano interesse. Può accadere anche che non comprendano fino in fondo, nonostante le griglie di valutazione, che cosa abbiano sbagliato, quanto sia grave l’errore e come evitarlo in futuro. Questo genera frustrazione. Servirebbe un processo di valutazione più orientato al dialogo con i ragazzi, che li aiuti a capire come migliorarsi. Sarebbe utile anche accordare loro fiducia attraverso valutazioni premianti, in modo che si sentano riconosciuti e motivati a mantenere il livello raggiunto piuttosto che tesi a una meta percepita come irraggiungibile.
Spesso, per esempio, preparo per i miei studenti piccoli giochi su Kahoot!, una piattaforma didattica diffusa nelle scuole. Possono essere quiz o altre attività in cui i ragazzi possono avvicinarsi alle discipline attraverso il linguaggio videoludico che riconoscono e apprezzano. In questo modo li vedo imparare più velocemente e con meno sforzo. Partecipano con entusiasmo, si sentono autorizzati a provare, anche a sbagliare, senza l’ansia della risposta giusta. Il fatto di condividere un linguaggio, quello dei videogiochi, con il docente cementa il rapporto di fiducia e permette loro di sentirsi compresi, incentivandone l’apertura e l’impegno.
L’unico limite è che, non essendo prove valutate, a volte gli studenti danno meno peso a queste attività.
La valutazione è un tema cruciale che può motivare ma anche avere l’effetto contrario: capita che alunni con difficoltà particolari si impegnino con costanza e poi, di fronte a un voto poco gratificante, perdano interesse. Può accadere anche che non comprendano fino in fondo, nonostante le griglie di valutazione, che cosa abbiano sbagliato, quanto sia grave l’errore e come evitarlo in futuro. Questo genera frustrazione. Servirebbe un processo di valutazione più orientato al dialogo con i ragazzi, che li aiuti a capire come migliorarsi. Sarebbe utile anche accordare loro fiducia attraverso valutazioni premianti, in modo che si sentano riconosciuti e motivati a mantenere il livello raggiunto piuttosto che tesi a una meta percepita come irraggiungibile.
Quali sono le difficoltà che incontra nel suo lavoro?
Ci sono molte difficoltà, perché spesso la distanza tra le teorie studiate durante la formazione o le prescrizioni burocratiche e la realtà quotidiana della scuola è enorme. Teorie splendide devono poi essere applicate a una classe di ragazzi in età puberale, in una fase di passaggio complessa, in cui abbiamo a che fare con bambini che vogliono comportarsi da adulti.
La scuola richiede molta burocrazia e prescrive metodi che non sempre sono attuabili in tutti i contesti. Prendiamo per esempio la parola “inclusione”, di cui, come insegnante di sostegno, sono particolarmente chiamato a occuparmi: è una parola bellissima, ma è appunto una parola, non può essere considerata un obiettivo finale, come avviene nei protocolli. Non è qualcosa che si raggiunge una volta per tutte, ma un processo continuo, che deve essere riconquistato ogni giorno con attività personalizzate in base alle fragilità dei singoli studenti. E ogni volta significa, in concreto, qualcosa di diverso.
Il PEI , il Piano Educativo Individualizzato, un documento che definisce obiettivi educativi, attività didattiche e metodi di insegnamento in relazione alle capacità dell’alunno, dovrebbe garantire questo percorso. Tuttavia, spesso ci viene richiesto di compilarlo molto velocemente, dopo poche settimane di osservazione dello studente: un tempo troppo breve per comprendere davvero come le fragilità del ragazzo si manifestino nelle diverse discipline. In teoria è possibile ritarare il piano più avanti, ma richiede passaggi burocratici complessi e a volte non si riesce a farlo per tempo.
Spesso si tratta di protocolli e tempistiche necessari, ma servirebbe maggiore flessibilità per permettere una costante attenzione alle individualità e ai contesti specifici.
La scuola richiede molta burocrazia e prescrive metodi che non sempre sono attuabili in tutti i contesti. Prendiamo per esempio la parola “inclusione”, di cui, come insegnante di sostegno, sono particolarmente chiamato a occuparmi: è una parola bellissima, ma è appunto una parola, non può essere considerata un obiettivo finale, come avviene nei protocolli. Non è qualcosa che si raggiunge una volta per tutte, ma un processo continuo, che deve essere riconquistato ogni giorno con attività personalizzate in base alle fragilità dei singoli studenti. E ogni volta significa, in concreto, qualcosa di diverso.
Il PEI , il Piano Educativo Individualizzato, un documento che definisce obiettivi educativi, attività didattiche e metodi di insegnamento in relazione alle capacità dell’alunno, dovrebbe garantire questo percorso. Tuttavia, spesso ci viene richiesto di compilarlo molto velocemente, dopo poche settimane di osservazione dello studente: un tempo troppo breve per comprendere davvero come le fragilità del ragazzo si manifestino nelle diverse discipline. In teoria è possibile ritarare il piano più avanti, ma richiede passaggi burocratici complessi e a volte non si riesce a farlo per tempo.
Spesso si tratta di protocolli e tempistiche necessari, ma servirebbe maggiore flessibilità per permettere una costante attenzione alle individualità e ai contesti specifici.
Ho visto insegnanti lasciare un segno profondo nella vita dei ragazzi: accendere passioni, aiutarli a immaginare un futuro prima impossibile. Ho notato che, in questi casi, esisteva un vero patto di corresponsabilità educativa tra docenti e genitori. Le famiglie, spesso in situazioni complicate, riconoscevano l’impegno degli insegnanti nella crescita umana dei figli e si affidavano a loro.
Secondo lei un insegnante può fare la differenza nella vita di uno studente?
Quando insegnavo a Roma, in un contesto particolarmente marginale, con molti studenti di recente immigrazione o provenienti da famiglie con fragilità, ho visto insegnanti lasciare un segno profondo nella vita dei ragazzi: accendere passioni, aiutarli a immaginare un futuro prima impossibile. Ho notato che, in questi casi, esisteva un vero patto di corresponsabilità educativa tra docenti e genitori. Le famiglie, spesso in situazioni complicate, riconoscevano l’impegno degli insegnanti nella crescita umana dei figli e si affidavano a loro.
Esistono però anche contesti in cui il docente viene giudicato e delegittimato sin da subito dai genitori. Quando questo accade, anche la fiducia degli studenti viene intaccata. I ragazzi, per quanto piccoli, colgono tutto: mezze parole, giudizi affrettati che circolano nelle chat dei genitori. È più che legittimo che le famiglie nutrano critiche, ma sarebbe opportuno che le esprimessero negli spazi dedicati, come i colloqui, all’interno del rapporto diretto con gli insegnanti. Diversamente, si rischia di minare il rapporto di fiducia tra i professori e i ragazzi, base su cui si reggono l’apprendimento e la crescita umana a scuola.
Esistono però anche contesti in cui il docente viene giudicato e delegittimato sin da subito dai genitori. Quando questo accade, anche la fiducia degli studenti viene intaccata. I ragazzi, per quanto piccoli, colgono tutto: mezze parole, giudizi affrettati che circolano nelle chat dei genitori. È più che legittimo che le famiglie nutrano critiche, ma sarebbe opportuno che le esprimessero negli spazi dedicati, come i colloqui, all’interno del rapporto diretto con gli insegnanti. Diversamente, si rischia di minare il rapporto di fiducia tra i professori e i ragazzi, base su cui si reggono l’apprendimento e la crescita umana a scuola.