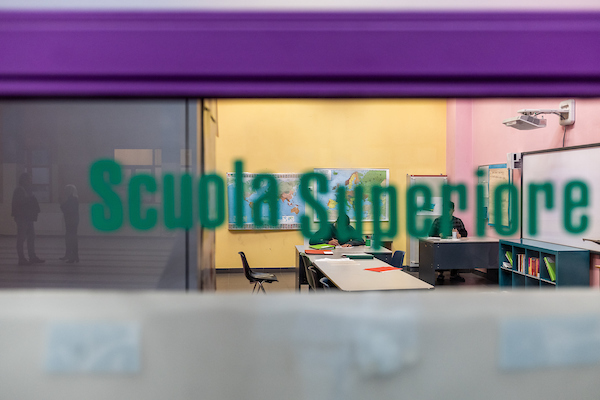Dove insegna? Quali sono le caratteristiche della scuola in cui lavora?
Da quanto tempo insegna?
A quali trasformazioni principali ha assistito/partecipato nel corso degli anni?
I ragazzi sono cambiati? Se sì, come?
In generale mi sento cambiata io: sono meno sicura rispetto alle attività che propongo! All’inizio mi sentivo più coraggiosa e forse ero più incosciente – ora il mio lavoro è più strutturato e pensato: mi chiedo sempre se il modo, l’argomento e il tema possono essere davvero utili ai miei studenti.
I ragazzi non mi sembrano tanto diversi, da un punto di vista esistenziale c’è sempre e solo l’oggi, non questa volta o domani. Forse a mutare è la loro analisi della realtà, che è frettolosa e frammentaria, ma la colpa non è loro: è un andamento generale, che dipende dal contesto in cui vivono. Bisogna cercare di proporre un’alternativa più ragionata se crediamo che serva per andare in una direzione nuova.
Se gli si dà il via, chiedono, sono curiosi, entusiasti, a volte più precisi di me: quando facciamo attività a lungo termine faticano un po’ perché vorrebbero un risultato immediato, ma poi mi aiutano a tenere il fuoco.
Mi piace molto, quando facciamo scuola tradizionale, dedicare tempo all’autovalutazione, perché non trovo giusto che i ragazzi subiscano un numero senza capire da dove arriva.
Che formazione ha ricevuto per fare questo lavoro?
Ho studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, un percorso bellissimo, importante. Ho conosciuto insegnanti significativi dai quali ho imparato tantissimo; e quello che ho imparato continuo a portarlo in classe, in termini non solo di contenuto singolo ma di forma mentis, di approccio all’arte e di pensiero sull’arte. A Bologna ho sentito qualcosa che si apriva e non sono mai più tornata indietro. Vorrei fare lo stesso con i miei ragazzi.
Questo processo è avvenuto perché ho incontrato docenti con stili diversi, accomunati da una visione comune che era l’andare oltre ciò che si studia, si legge e si vede. Ho quindi frequentato la Cobaslid, cioè la SIS per le discipline artistiche, all’Accademia di Venezia (già insegnavo qui sul territorio), mentre la parte pedagogica era a Ca’ Foscari. Percorso utile, soprattutto perché c’era un ottimo confronto con i colleghi: avevamo già tutti un piede nella scuola.
Mi ha aiutato molto anche il lavoro in museo come guida e come accompagnatore didattico: grazie a questa esperienza ho toccato con mano il contatto con l’opera e anche la sfida al breve tempo a disposizione, dato che la classe si ferma un paio d’ore e deve tornare a casa con un’esperienza piena, con il superamento del pregiudizio sul museo e sull’arte.
Poi, chi lavora a scuola ha la fortuna di avere una formazione continua, sia quella istituzionale sia quella che avviene in modo autonomo e attraverso canali non convenzionali: tutti gli stimoli, prima o poi, finiscono in classe… nomi, idee, suggestioni ricompaiono e sono utili. Trovo molto significative le formazioni non legate alla disciplina di insegnamento, che arricchiscono moltissimo il lavoro in aula. D’altra parte la contaminazione non è un’invenzione di oggi, basta pensare a Leonardo, c’è sempre stata e ha portato a grandi cose.
Di quali altri strumenti sente di aver bisogno per seguire ed educare i suoi studenti in modo più pieno ed efficace?
Quali sono gli ostacoli maggiori a far bene il suo lavoro?
Che cosa introdurrebbe di nuovo nella scuola?
Venendo alla mia disciplina, penso che le indicazioni nazionali sui contenuti dovrebbero lasciarci più liberi e autonomi nella scelta; preferirei avere a che fare con meno vincoli, meno rigidità. Come posso trattare tutta la storia dell’arte? Sarebbe meglio selezionare dei periodi e degli artisti per sviscerarne la poetica in modo più approfondito, piuttosto che fare la carrellata di cento opere e cento artisti in modo superficiale.
Quale è il suo approccio all’insegnamento?
Sono comunque una fan della lezione frontale: i ragazzi devono imparare ad ascoltare, a prendere appunti e ad avere un tempo lento. Inoltre mi piace molto, quando facciamo scuola tradizionale, dedicare tempo all’autovalutazione, perché non trovo giusto che i ragazzi subiscano un numero senza capire da dove arriva, mi piace che possano rielaborare quello che hanno fatto in termini consapevoli. Nessuno fa lo spiritoso, anzi, è uno sforzo incredibile e fruttuoso. Serve tempo e per questo lo uso volentieri.
Crede che un insegnante possa fare la differenza per i suoi alunni?
Ha qualche progetto in mente?
Mi piace molto l’educazione all’immagine e con l’immagine, ed è per me importante ristabilire confini definiti. A 16, 17 anni si esce dal sé andando verso l’universale; in questo passaggio una lettura oggettiva dell’immagine li aiuta molto a crescere, a lasciarsi alle spalle l’autoreferenzialità soggettiva e a liberarsi dal diario segreto dell’adolescente.