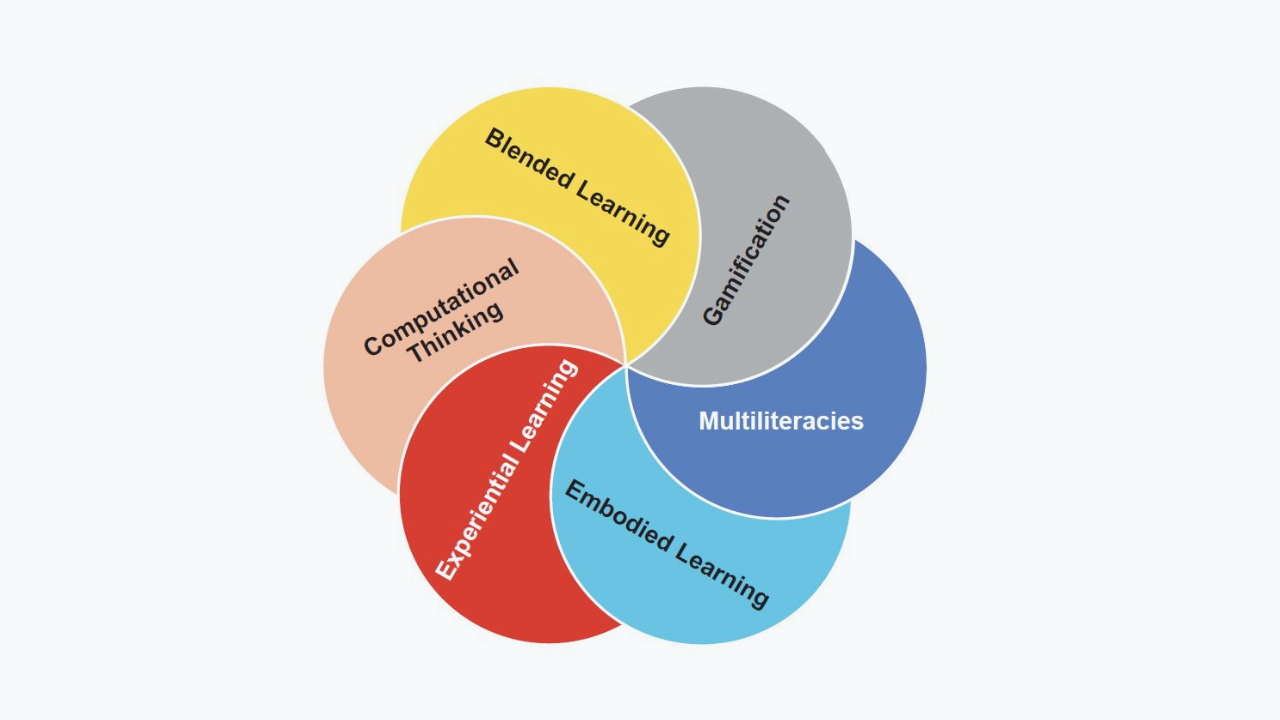Quando ho terminato l’istituto tecnico industriale non volevo continuare a studiare, perché avevo vissuto molto male gli anni delle superiori. Poi ho svolto il servizio militare in Friuli, dove ho conosciuto commilitoni provenienti da zone periferiche d’Italia che, lavorando già da tempo, hanno approfittato dell’anno di servizio per completare gli studi, prendendo la licenza elementare o la media. Quando la sera tornavamo dalle esercitazioni, verso le 10, dovevano studiare e mi chiedevano aiuto o spiegazioni. Quest’esperienza ha avuto un forte impatto su di me e ho iniziato a pensare che mi sarebbe piaciuto insegnare. Proprio per questo ho deciso di iscrivermi all’università, scegliendo Matematica, la disciplina che preferivo da sempre. Mi motivava non solo l’idea di dare una possibilità a persone come quelle che avevo conosciuto durante il servizio militare, ma anche, viste le brutte esperienze che avevo vissuto alle superiori, il desiderio di cambiare la scuola dall’interno.
Per questo, per me, un aspetto cruciale è la condivisione: li faccio spesso lavorare in gruppo, in modo che ciascuno possa diventare uno strumento di crescita per i propri compagni. Il mio è un approccio cooperativo, ispirato a quello che viene chiamato cooperative learning (approccio didattico in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi per raggiungere un obiettivo comune).
Coerentemente con questa modalità didattica, la valutazione, per quel che mi riguarda, non coincide con il momento della verifica, ma è un percorso che parte dall’osservazione iniziale degli studenti e procede grazie alla possibilità di vederli in azione giorno per giorno. Nel cooperative learning, infatti, a differenza della lezione frontale, i ragazzi sono stimolati a fare domande e a cercare soluzioni insieme. In questo modo posso osservarli e trasformare la valutazione in un momento di dialogo, di orientamento.
La valutazione per me è parte integrante dell’insegnamento, non una sua ricaduta. Non vado a verificare quanto gli studenti hanno imparato, ma li accompagno per capire, e far capire loro, a che punto si trovano nel percorso di apprendimento, dove stanno andando e come possono migliorare.
I feedback che do ai ragazzi non si limitano a dire “questo è giusto” o “questo è sbagliato”, ma cercano di andare più a fondo, indicando perché una scelta è stata efficace e un’altra no, e quali passi possono servire per procedere. Più che uno strumento di giudizio, si tratta di un gesto di responsabilità: è il momento in cui l’insegnante restituisce il senso di ciò che è successo in classe. E non è l’ultima parola, ma l’inizio di un dialogo.
Nella mia scuola, insieme ad altri docenti, abbiamo avviato una sperimentazione coerente con questa visione della valutazione, in accordo con la libertà concessa dalla normativa che non obbliga a conferire voti durante il corso dell’anno, ma solo in chiusura. In questi giorni, alla fine dell’anno scolastico, sto tenendo colloqui individuali con i ragazzi per capire com’è andata e devo dire che mi hanno dato bellissimi riscontri: si sentono responsabilizzati.
Ma questo tipo di valutazione “senza voti” serve anche a me, l’insegnante, perché mi obbliga a guardare con più attenzione ciò che propongo in classe e a capire se funziona. Si instaura così un ascolto reciproco tra docente e studenti, che è poi l’unico modo per migliorare la didattica e renderla più efficace.
La valutazione per me è parte integrante dell’insegnamento, non una sua ricaduta. Non vado a verificare quanto gli studenti hanno imparato, ma li accompagno per capire, e far capire loro, a che punto si trovano nel percorso di apprendimento, dove stanno andando e come possono migliorare.
Io credo che anche in tal senso un nuovo sistema di valutazione possa essere uno strumento utile per accogliere questa fragilità e far emergere le risorse degli studenti, piuttosto che le loro mancanze, affinché la scuola non selezioni, ma accompagni. Spesso la valutazione è vissuta come il proscenio di un palcoscenico, un momento in cui si ha il terrore di fare brutta figura, di deludere o, peggio ancora, di ricevere un giudizio che può chiudere porte verso il futuro. Ma il problema non è l’errore, anzi spesso proprio quello è il punto di partenza per apprendere. Se non c’è spazio per sbagliare, non si capisce perché si dovrebbe venire a scuola.
Fa la differenza quando non si nasconde dietro al programma da finire o al voto da dare, ma si prende il tempo per quello sguardo in più, che a volte cambia tutto. Quando ho iniziato a insegnare, un professore anziano mi disse che, di fronte a uno studente in difficoltà, a volte è molto più utile sedersi accanto a lui, piuttosto che insistere su ciò che non sta capendo.
Ecco, io credo che non si tratti di essere bravi, ma di essere presenti.