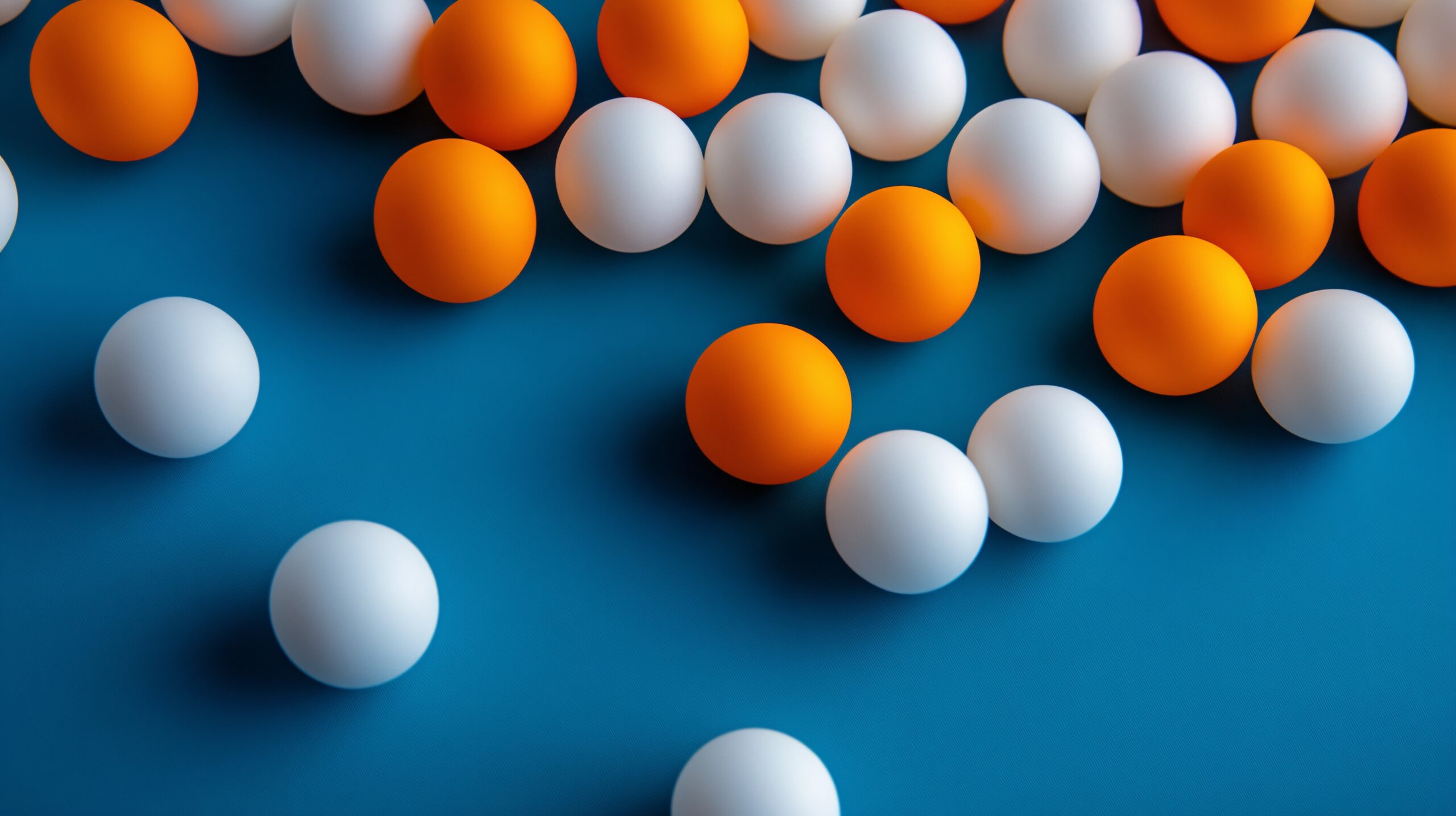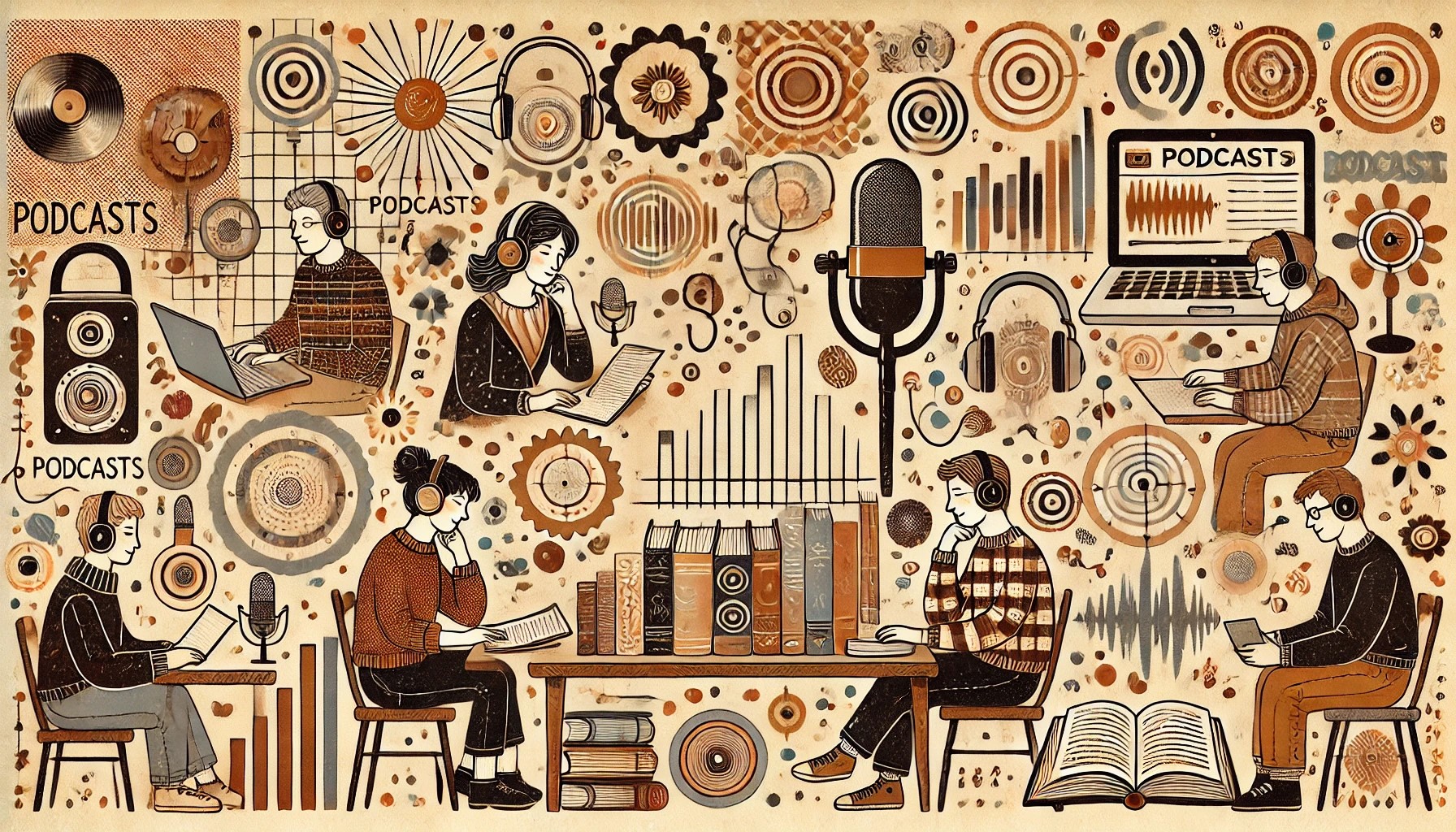Da bambina che rapporto aveva con la lettura e con la scuola?
Leggevo moltissimo. Ho iniziato con le fiabe sonore e, ancor prima di saper leggere, accompagnavo con il dito il ritmo della narrazione: un gesto che mi è rimasto. Quando scoprivo un autore o un’autrice che amavo, come Bianca Pitzorno, volevo leggere tutto. E se finivano i libri a disposizione, passavo a ciò che trovavo in casa, persino agli Harmony di mia nonna.
Mi piaceva andare a scuola, soprattutto durante le ore della maestra Rosa, l’insegnante d’italiano. Aveva istituito “l’ora di lettura”, in cui potevamo leggere in silenzio, per poi guidarci con la sua voce alla scoperta di nuovi testi. Con lei ho sperimentato anche il piacere della scrittura, adoravo in particolare i temi descrittivi. Presto ho iniziato a scrivere anche al di fuori della scuola, riempiendo i quaderni a quadretti. La prima storia che ricordo, in prima elementare, si chiamava Il fantastico mondo scoperto in un tombino, poi è arrivato Il diario di Brigitta, una storia che ho continuato a scrivere per un anno intero, abbozzandone anche i disegni. Sarebbe bello se la scuola aiutasse i bambini a scrivere anche liberamente, seguendo la fantasia, al di là dei programmi e della valutazione, per il piacere di farlo.
Dopo il dottorato in Scienze della Formazione, in cui si è occupata di letteratura per l’infanzia, continua a fare ricerca e a insegnare all’università su questi temi. Che rapporto c’è tra le sue ricerche e la sua attività di scrittrice?
Come docente e ricercatrice cerco di sottolineare che la letteratura per l’infanzia non è inferiore a quella per adulti e può essere considerata una forma d’arte. C’è un equivoco per cui i libri per bambini non avrebbero dignità letteraria. Per secoli, all’infanzia non è stato riconosciuto uno statuto e, anche quando si è iniziato a farlo, le opere a essa dedicate avevano per lo più intenti edificanti, preparavano i bambini all’età adulta.
Quando studiavo Lettere Moderne ero già appassionata di letteratura per l’infanzia, e, anche se non era previsto dal mio corso, ho sostenuto un esame a scelta su questa disciplina dove, però, l’approccio era pedagogico: si studiavano i testi adottati nella storia della scuola italiana, non si analizzavano i libri in chiave letteraria, piuttosto si evidenziava il loro scopo educativo. Durante il dottorato, ho scoperto che altrove, in ambito angloamericano per esempio, esiste una percezione diversa, già a partire dal termine children’s literature (letteratura dei bambini), che include anche libri non scritti originariamente per bambini, come quelli di avventura di Swift o Verne, ma “adottati” nel tempo dai ragazzi. Un momento importante di autodeterminazione di questa letteratura avviene nel 1865, quando Lewis Carroll scrive Alice nel Paese delle Meraviglie: un libro che non mira a veicolare un messaggio, ma a intrattenere e stimolare la fantasia, anche attraverso il nonsense.

Il barattolo dei desideri
Qual è quindi il rapporto tra pedagogia e letteratura per l’infanzia?
Nella letteratura per l’infanzia sono gli adulti a scrivere per i bambini: questa discrepanza tra autore e lettore apre la strada alla visione pedagogica dell’adulto, a volte anche rivoluzionaria. Come nel caso dei capolavori di Astrid Lindgren, uno su tutti Pippi Calzelunghe, che trasmettono i principi di un’educazione libera e aperta (in linea con la cultura svedese), tanto da suscitare critiche e un certo scandalo nell’Italia degli anni Cinquanta. Ma ci sono anche libri meravigliosi che non hanno un intento esplicito, come quelli di Roald Dahl: semplicemente permettono ai bambini di perdersi e ritrovarsi in un universo altro. Fare esperienza del mondo attraverso la lettura è di per sé formativo. Come autrice, preferisco partire dai personaggi e dal loro percorso, invece che caricarli del compito di insegnare a tutti i costi qualcosa.
Fare esperienza del mondo attraverso la lettura è di per sé formativo. Come autrice, preferisco partire dai personaggi e dal loro percorso, invece che caricarli del compito di insegnare a tutti i costi qualcosa.
Ha incontrato molte volte i suoi giovani lettori nelle scuole. Com’è oggi il rapporto dei bambini con la lettura? La scuola li sostiene nella scoperta dei libri?
Il lavoro fatto dagli insegnanti con i bambini su un libro determina la profondità della loro lettura. Il compito della scuola dovrebbe essere quello di aiutare i bambini a farsi domande e a far risuonare ciò che leggono con la propria storia.
Quando ho presentato La ricetta della felicità, romanzo che ha per protagonista una ragazzina di seconda generazione, molti insegnanti hanno lavorato sul tema delle identità culturali plurali. Alcune classi hanno creato ricettari con piatti della propria tradizione, altre hanno scritto finali alternativi. In seguito, durante gli incontri, soprattutto i bambini di seconda generazione si sono sentiti protagonisti e hanno condiviso le loro emozioni.
Se in classe è stato fatto un buon lavoro, emergono anche domande intime che diventano occasione per esplorare il proprio mondo interiore. Per Il barattolo dei desideri porto con me un barattolo in cui raccogliere sogni scritti su post-it anonimi. Ho scoperto così che i bambini da un lato hanno aspirazioni (che lavoro fare, chi diventare), dall’altro desiderano liberarsi dalle paure, come il timore che i genitori litighino o quello di essere esclusi dai compagni. Esercizi ispirati dalla lettura possono diventare chiavi per accedere all’interiorità dei bambini e, per gli insegnanti, occasioni per conoscerli meglio.
Nel processo creativo da quali elementi parte per creare le storie?
A volte è la casa editrice a suggerire un macrotema: per esempio Non mi piace andare a scuola (Mondadori) fa parte di una trilogia iniziata da un’altra autrice, Miriam Dubini. Ma quando scrivo liberamente, prendo il via quasi sempre dal personaggio. Mi ispiro a situazioni e figure contemporanee, ma nel descrivere l’interiorità attingo anche alla mia esperienza. Nella Ricetta della felicità, come dicevo, sono partita da una ragazzina di seconda generazione dei nostri giorni, ma, per raccontare i suoi rapporti con i compagni e le sue insicurezze, ho ripescato il mio vissuto. Anche Il barattolo dei desideri è nato da un personaggio: un bambino che ama esprimere i suoi desideri. In questo mi hanno influenzato Andrew Offiler e Robin Lyons, con cui ho lavorato in una casa di produzione di cartoni animati in Galles. Andrew, che è anche illustratore, parte sempre dal personaggio, disegnandolo, convinto che, se è ben costruito, la storia segua da sé.

Le illustrazioni sono di Sara Brienza, tratte da Il barattolo dei desideri di Eleonora Fornasari.
È anche sceneggiatrice di cartoni animati e autrice di programmi TV per bambini. Questo tipo di scrittura influenza quella per i libri?
Sì, la scrittura per l’audiovisivo mi ha portato a pensare molto per immagini e a visualizzare ciò che racconto.
Influisce anche sull’attenzione al linguaggio. Nel mondo dell’animazione i target sono molto precisi: certi temi e stili sono adatti all’età prescolare, altri a bambini dagli otto ai dieci anni. In letteratura questi confini sono più sfumati e c’è più libertà, anche rispetto a ciò che i personaggi possono o non possono fare. In ambito televisivo, soprattutto nel servizio pubblico, c’è un intento educativo molto forte.
Scrivere per l’animazione obbliga anche a un aggiornamento e a un’attenzione costante a ciò che piace ai bambini di oggi. Gli stessi colleghi sceneggiatori gallesi di cui parlavo mi hanno anche insegnato a osservare i bambini, per esempio frequentando i musei preferiti dai più piccoli, per scoprire cosa li accende di curiosità. Un approfondimento utilissimo anche per i miei libri.
Se dovesse scegliere tra i suoi libri quello a cui è più affezionata?
Direi La ricetta della felicità, non solo perché è il mio primo romanzo in senso proprio, ma anche perché affronta temi da me molto sentiti. Non ho fatto esperienza di persona della situazione della protagonista, una ragazzina di origine egiziana in Italia, ma l’ho vissuto attraverso la storia e i racconti di mio marito. Da sempre mi affascina il tema dell’identità culturale e dell’incontro tra culture diverse. Già prima di viverlo nella mia storia personale, sentivo il desiderio di esplorarlo attraverso la narrazione. In quel libro c’è molto di me, trasfigurato, ma vicino al mio percorso.
Eleonora Fornasari
Dopo aver conseguito un Master in Scrittura e Produzione per la Fiction e il Cinema presso l’Università Cattolica di Milano, dal 2011 collabora con Rai Kids come autrice e sceneggiatrice per numerosi programmi e serie TV (La posta di YoYo, La TV ribelle, Giulio Coniglio, Yo Yo, Topo Gigio, Gli Acchiappagiochi, Minieroi della foresta, Kapuf – Piccolo mostro e S-fidiamoci). Questa esperienza nella produzione di contenuti televisivi per bambini l’ha portata a conseguire un dottorato di ricerca, esplorando un percorso che unisce letteratura e audiovisivo. Successivamente, ha pubblicato numerosi libri per bambini con editori di primo piano come Mondadori, DeAgostini, Paoline e Il Castoro. Attualmente, insegna Writing Producing for Animation all’interno della laurea magistrale The Art and Industry of Narration dell’Università Cattolica. Conduce anche il laboratorio di Formati della scrittura mediale. È docente di Digital Journalism and Digital Media in Italy e The Female Character in Italian Contemporary Literature and Culture nell’International Curriculum della stessa università, oltre a Storia e Teoria dei nuovi media al SAE Institute di Milano.