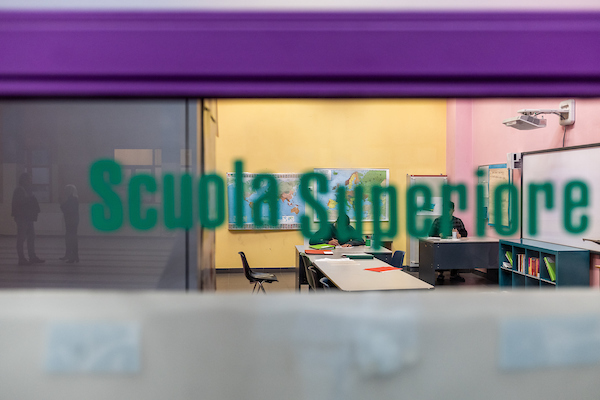Dove insegna e qual è stata la sua formazione?
Insegno all’Istituto Cardarelli di La Spezia, una scuola secondaria di secondo grado con tre indirizzi: liceo artistico, liceo musicale e costruzione, ambiente e territorio (CAT, l’istituto per diventare geometri). Sono docente curricolare di inglese al Liceo artistico e all’Istituto per geometri e tengo corsi extracurricolari di spagnolo e di arabo. Sono arrivato piuttosto tardi, sei anni fa, a insegnare la mia materia curricolare. Prima ho lavorato a lungo con la scuola come consulente linguistico, mediatore e docente di italiano come seconda lingua. La mia grande passione sono le lingue: prima di diventare insegnante ho svolto altri lavori in cui era cruciale la competenza linguistica, a partire dall’export vinicolo per l’azienda di famiglia, passando poi per la professione di giornalista e per il teatro, dove ho collaborato a spettacoli dedicati al tema dell’immigrazione.
Nelle sue lezioni su quali aspetti didattici si concentra?
Il presupposto della mia didattica è innanzitutto far capire agli studenti che la lingua straniera serve concretamente, non è una materia astratta. Per questo prediligo i cosiddetti compiti di realtà, in cui propongo una situazione che gli studenti devono risolvere attraverso l’uso dell’inglese. Do loro un obiettivo preciso, come raccogliere informazioni su un tema o cavarsela in una determinata circostanza, anche attraverso il roleplaying (simulando una situazione e assegnando un ruolo da “recitare” ai diversi studenti). In questo modo possono acquisire le strutture e il lessico mettendoli in pratica. La mia materia mi facilita, perché i miei studenti si trovano di continuo di fronte a situazioni in cui è evidente l’utilità di saper parlare un’altra lingua. La nostra è una città di mare, turistica, e in estate è piena di stranieri, così invito i miei ragazzi a usare l’inglese per interagire, per fare conoscenze e conversazione.
Nel corso degli anni ha assistito a cambiamenti e trasformazioni della scuola?
Rispetto alla scuola che ho frequentato io, negli anni Novanta, noto un progressivo cambiamento in una direzione che valuto come positiva: al netto di tutte le difficoltà e delle possibili lamentele, la scuola di oggi è più umana. C’è molta più considerazione per i singoli studenti, per i disturbi dell’apprendimento, per gli stati d’ansia, per i bisogni educativi speciali. Certo, in alcuni casi si può eccedere, ma ritengo sia meglio così piuttosto che la mancanza di consapevolezza dei tempi in cui ero studente io. Nell’età della scuola dell’obbligo, spesso si rischia di essere identificati dalla società e persino dai genitori con il proprio rendimento scolastico e, se ripenso a tanti miei compagni di scuola ai quali oggi magari avrebbero diagnosticato disturbi dell’apprendimento o altri bisogni educativi speciali, posso capire quanto per loro possa essere stato difficile attraversare gli anni della formazione.
Quali sono oggi gli strumenti di cui un docente dispone per rispondere a situazioni come quelle che ha citato?
Innanzitutto, al docente di oggi si richiede un cambio di prospettiva a monte che consiste nel rendersi conto che non ha di fronte studenti tutti uguali, ma individui con caratteristiche peculiari, tra cui, a volte, anche disturbi, come quelli dell’apprendimento. La scuola di oggi riconosce e incoraggia questa prospettiva e mette a disposizione strumenti utili per personalizzare la didattica e stimolare tutti i tipi di intelligenza. È possibile disporre di supporti audio e video, di infiniti materiali reperibili in rete, attivando diversi modi di percepire e apprendere. Inoltre, è incoraggiata la sperimentazione di diverse modalità didattiche. In linea teorica, secondo la formazione che oggi gli insegnanti ricevono all’inizio del loro percorso e attraverso i corsi di aggiornamento, la lezione frontale tradizionale dovrebbe essere riservata a un numero limitato di casi. Esistono molte altre modalità: l’apprendimento cooperativo, la classe ribaltata (in cui gli studenti studiano a casa i contenuti e li rielaborano in classe attraverso attività partecipative con insegnanti e compagni), i compiti di realtà, i lavori di gruppo. Certo, a volte queste possibilità possono rimanere sulla carta, perché spetta poi al singolo docente, nell’infinita variabilità delle età anagrafiche e delle formazioni, sperimentarle nella propria didattica. Nella mia esperienza, procedo attraverso una serie di tentativi ed errori per cercare di capire quale modalità funzioni per il singolo argomento e per le diverse classi. Credo sia importante mettersi in gioco, prendere atto che esistono molti modi di insegnare, diversi da quelli con cui abbiamo imparato noi, e che, al contempo, esistono molti tipi di intelligenza da stimolare.
Credo sia importante mettersi in gioco, prendere atto che esistono molti modi di insegnare, diversi da quelli con cui abbiamo imparato noi, e che, al contempo, esistono molti tipi di intelligenza da stimolare.
Qual è la difficoltà più grande nella sua professione?
Prima ho parlato di una trasformazione positiva della scuola verso un approccio più umano. Ora, per rispondere a questa domanda, devo prendere in considerazione l’altro lato della medaglia. Questo cambiamento comporta anche che gli studenti portano in classe tutto: il disagio, l’ansia, la svogliatezza. Se una volta gli studenti potevano provare pudore nel confessare di non aver fatto i compiti, per esempio, ora lo dicono senza problemi. All’insegnante vengono confidati vissuti difficili, situazioni familiari fragili, e il docente curricolare di una determinata disciplina si trova a essere, in certe situazioni, al contempo psicologo, ortopedico, familiare, amico. Ma noi non siamo nulla di tutto questo e, se da una parte è importante prendere in considerazione la personalità e l’esperienza di ogni studente, dall’altra è anche utile stabilire dei confini, fare un po’ di ordine, per poter tutelare il proprio ruolo. Anche perché non si tratta solo degli studenti, ma anche dei genitori, che spesso portano agli insegnanti problemi e disagi che andrebbero gestiti in famiglia e su cui il docente ha scarso margine d’azione. Questo aspetto nuovo, che ha a che fare con il cambiamento della società, della genitorialità e dei rapporti tra adulti e ragazzi, rende la professione di insegnante più sfidante, anche più bella in un certo senso, ma di certo più difficile.
Secondo lei un insegnante può fare la differenza nella vita degli studenti?
Gli studenti passano molto tempo con noi, portandoci le loro difficoltà, i loro complessi di inferiorità, il loro bisogno di essere valorizzati, e a tutto questo noi rispondiamo, dando loro input che poi, in maniera più o meno consapevole, rielaborano. Quindi il ruolo del docente è decisivo, e non solo per quanto riguarda l’apprendimento della materia curricolare. Inoltre, la scuola è il primo spaccato di mondo adulto con cui vengono in contatto dopo la famiglia e permette loro di capire che “i grandi” non sono tutti uguali, che tra loro ci sono infinite differenze e sfumature, che i ragazzi sono sensibilissimi a cogliere. Quindi sì, di sicuro il docente lascia un segno. A volte in senso positivo, altre volte invece, quando non cogliamo qualcosa di loro, per esempio il bisogno di uno studente di essere valorizzato, si può anche lasciare un segno grigio, ambivalente. Ogni giornata è una nuova sfida in cui si ricomincia da capo, con la possibilità di lasciare segni diversi.